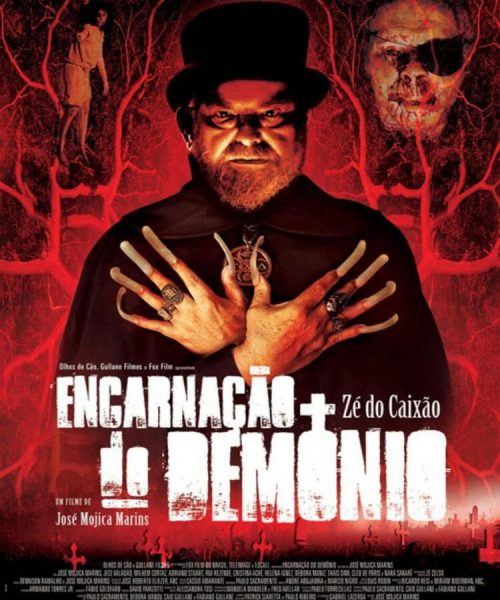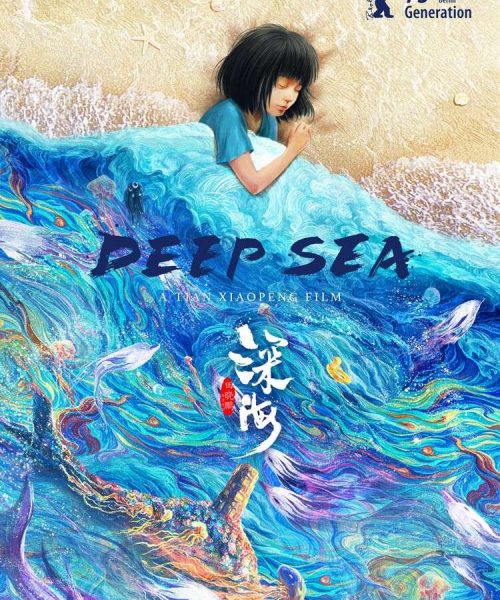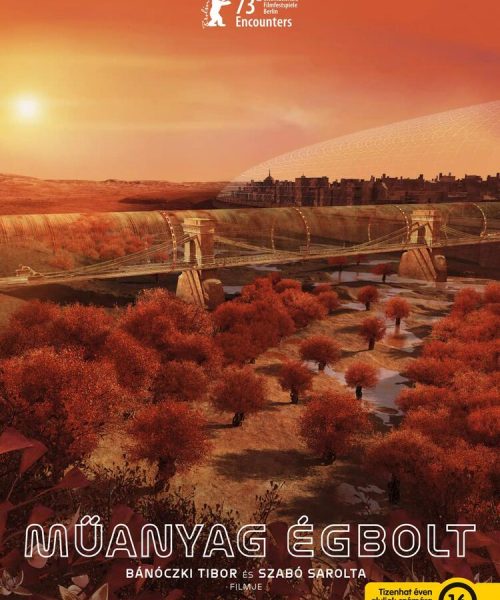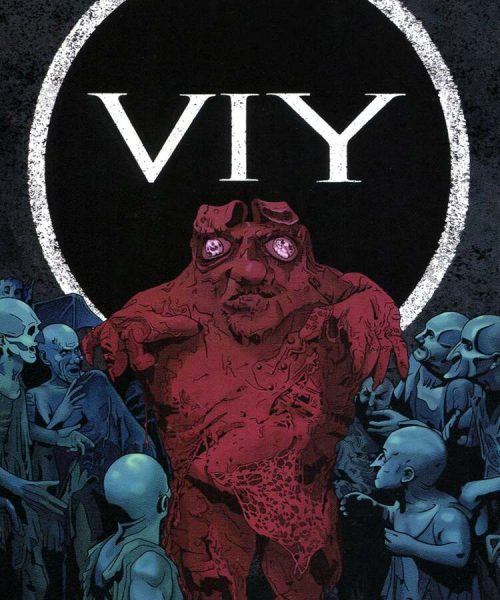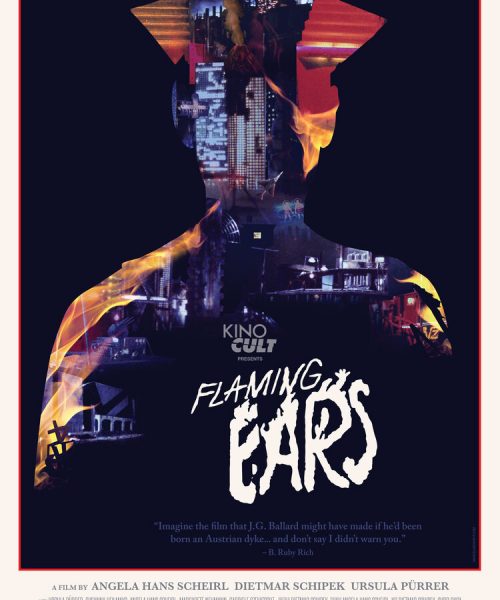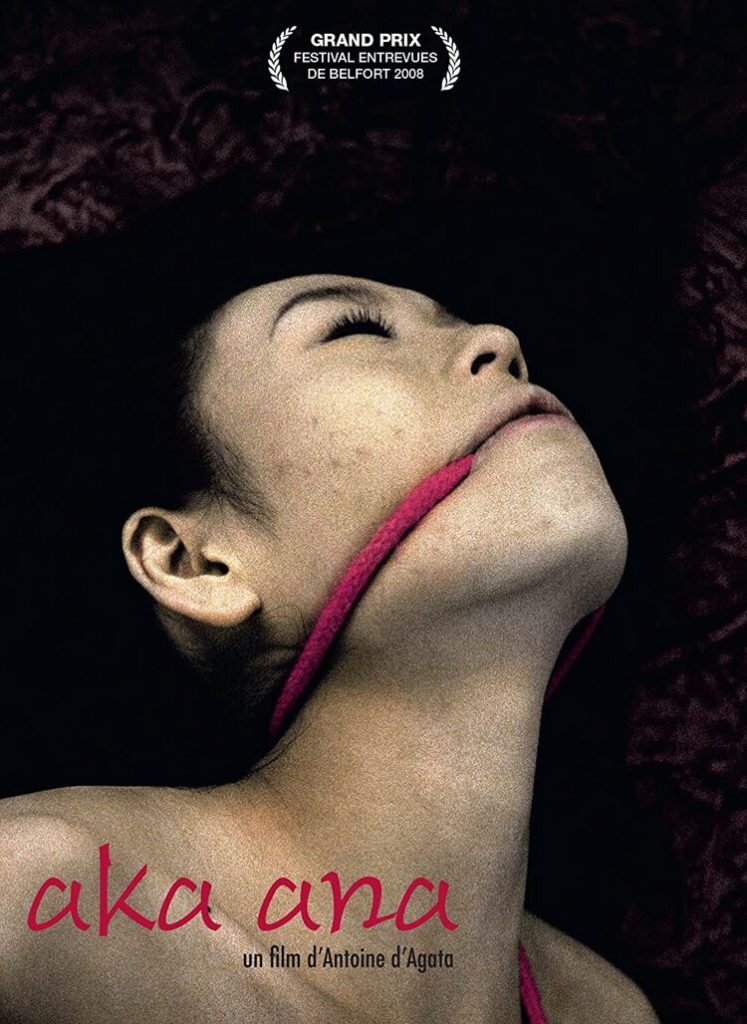
Titolo originale: Aka ana
Nazionalità: Francia
Anno: 2008
Genere: Drammatico
Durata: 60 min.
Regia: Antoine d’Agata
Alcune storie di prostitute giapponesi, che raccontano in prima persona le proprie esperienze sessuali.
In fondo non stupisce che d’Agata sia passato dalla fotografia al cinema; il cinema, infatti, ha questo strano potere di collocare il reale ripreso in una temporalità che è immediatamente demiurgica, e i corpi che d’Agata fotografa e riprende sono come l’essere necessario di Leibniz, esistentificante: esistono perché devono esistere, e in questo senso l’operazione di d’Agata trascende d’Agata stesso, ne fa come un veicolo di qualcosa di superiore, che è l’esistentificazione dei corpi per l’appunto. Corpi martoriati, spastistici, che si agitano nell’ombra poiché appartengono all’ombra, corpi quindi che sono già tombe. Ma ogni tomba è simulacro di un qualcosa che è venuto prima e a cui ora fa da letto, sicché Aka ana, come sarà poi per Atlas (Francia, 2013, 76′), non è che un muro, uno schermo bianco sul quale quei fantasmi possano infine scagliare le proprie ombre e vivere in esse, per esse, come ombre, ovvero come simulacri, come qualcosa di trascorso che permane, vive ed esiste – ma in maniera (ora) nuova, originale. È una questione di autenticità, nient’altro, e come tale la si può comprendere esclusivamente nell’ottica fornitaci da Tommaso Lusena de Sarmiento e Giuseppe Schillaci attraverso il loro The cambodian room: Situations with Antoine D’Agata (Italia/Francia, 2009, 55′), poiché è solo in prospettiva a quel frammento di vita che l’estetica di d’Agata intercede e, anzi, s’installa nell’esistenza, che è nostra.
Che è nostra: un piano d’immanenza si stende lungo tutto il senso dell’essere, e noi ci troviamo come collegati a quelle sagome che si fanno sempre più incipienti, sempre più incipienti, sempre più incipienti fino a collassarci addosso – e Aka ana è nient’altro che questo stesso collasso, ed è definitivo (come tale), perché ne usciamo segnati, inevitabilmente; si capisce bene, allora, la scelta di abusare del ralenti, in base alla quale, forse, diviene più chiara anche la nostra condizione borghese di spettatori, poiché esso d’Agata intende infondo proiettare noi stessi nella pellicola, il che significa renderla fruibile, sì, ma questa resa di fruibilità implica necessariamente tra spettatore e spettacolo un dislivello che, qualora non fosse presente, farebbe dello spettatore lo spettacolo stesso: «Quello che la mente non ha il tempo di trattenere, quello che l’occhio non ha né il tempo né il campo visivo necessari per vedere in un’espressione – i prodromi, la nascita, l’evoluzione, la lotta tra i sentimenti intercorrenti che compongono alla fine la loro risultante – tutto questo, il ralenti lo mostra a volontà.
E le dimensioni dello schermo permettono di esaminarlo come sotto una lente di ingrandimento. Lì, le migliori menzogne restano prive di forza, mentre la verità esplode a prima vista, colpisce lo spettatore con l’immediatezza dell’evidenza, suscita in lui un’emozione estetica, una sorta di ammirazione e di piacere infallibili» (Jean Epstein, L’essenza del cinema). È l’unico momento, questo, in cui d’Agata compare, e compare (con ralenti) per poi scomparire (nel ralenti), trasformando così la visione di Aka ana in una sorta di immersione in cui non si può che morire annegati. Ma morire, come abbiamo visto, significa riflettere se stessi sullo schermo bianco che d’Agata ci fornisce, e in tal senso è un vivere pure questo, tant’è che la morbosità e l’ossessività con cui viene ripreso l’atto più istintuale e sessuale che un essere possa compiere (la droga, il sesso. Che del resto sono la stessa cosa, così come la incarna d’Agata nel suo cinema e nella sua esistenza) si spiegano infine proprio nel loro repentino attuare la vita, nel loro infinito essere l’unica estrinsecazione possibile della potenzialità che è specifica di chi vive ed è, appunto, la vita stessa. No, non si tratta affatto del dittico freudiano Eros e Thanatos quanto, piuttosto, di un’unità originaria da cui questi discendono per degradazione continua – e d’Agata è un prometeo, un martire, perché è riuscito, pagando il fio sulla/colla propria pelle, a mostrarcela, questa unità.
Recensione: emergeredelpossibile.blogspot.it
Il mio sforzo, lo so bene, è disperato: il lampo che mi abbaglia – e che mi folgora – avrà reso ciechi solo i miei occhi.1 Georges Bataille, Madame Edwarda (1937)
Preferisco una foto pessima che documenta la mia reale interpretazione nel mondo rispetto a una foto eccellente in cui sono un voyeur o un inutile testimone.2 Antoine d’Agata
Chi ha seguito il percorso artistico e umano del fotografo francese Antoine d’Agata non si sarà sorpreso della scelta di quest’ultimo di passare, seppur episodicamente, al mondo del cinema. Tra le prime pubblicazioni fotografiche di d’Agata e quelle più recenti, infatti, è subentrata una novità che ha influenzato in modo decisivo non solo la fotografia ma anche la decisione dell’autore di abbracciare il mondo del video. La novità consiste nell’oltrepassamento del confine che separa metteur en scène e soggetto. In altre parole, si assiste a un cambiamento radicale del ruolo dell’artista all’interno del quadro: non più testimone passivo, il fotografo della Magnum diventa vero e proprio protagonista. Di fatto, nell’universo di d’Agata, l’esperienza e il coinvolgimento personali dell’autore sono infinitamente più importanti della cura formale dell’opera. In altre parole, ciò che succede sul set (fotografico o cinematografico, cambia poco) non è meno significativo del prodotto finale; anzi, il processo – l’esperienza – che precede e permette la realizzazione dell’opera di d’Agata è, il più delle volte, l’opera stessa. Utilizzando le parole del fotografo, «Non è importante il modo in cui il fotografo guarda il mondo, ma la relazione intima che vi è tra i due.»3
I film e le fotografie dell’autore di Vortex (2003), pertanto, non sono nient’altro che il diario di un’esperienza, un journal du tournage che utilizza il cinema non come un fine ma piuttosto come un mezzo attraverso cui d’Agata rende possibile il costruirsi di una relazione intima con il set e le ragazze che fotografa/riprende. Il “patto” che precede la realizzazione dell’opera è il seguente: nulla viene nascosto all’occhio della macchina fotografica (della cinepresa); il coinvolgimento deve essere totale. Il fotografo (il regista) è protagonista, assieme alle ragazze; è il soggetto dell’opera e colui che, assieme a loro, la realizza; attante prim’ancora che metteur en scène.
Per questo, non vi è spazio, nel processo di realizzazione dell’opera, per ripensamenti morali. Piuttosto, la morale è intrinseca al gesto, alla disperazione del gesto: bucarsi, scopare, picchiare ed essere picchiati; fotografare e fotografarsi; filmare e filmarsi. Fatta questa premessa necessaria, il lungometraggio Aka Ana [id., 2008] si configura come un perfetto prolungamento dell’opera fotografica di d’Agata, una summa del percorso artistico (e umano) dell’autore di Vortex e Stigma (2004) e, allo stesso tempo, un film che prefigura una svolta.
Nel 2006, d’Agata scrive una sceneggiatura ispirandosi a Madame Edwarda (1937) di Georges Bataille, romanzo breve che racconta la notte frenetica e disperata di un uomo in compagnia di una prostituta. Tra Settembre e Dicembre di quell’anno, il fotografo va in Giappone, dove gira una prima versione della sceneggiatura, una installazione video della durata di 22 minuti per una esposizione alla Cinémathèque. D’Agata gira in DV, alternando fotografie e immagini in movimento. Il lungometraggio del 2008, Aka Ana, nasce da quest’esperienza. È un’opera ibrida, una sorta di diario intimo delle notti giapponesi del regista, che alterna frammenti dal forte impatto formale ad altri che hanno un rapporto diretto, non fantasmatizzato con il reale. Rispetto al successivo Atlas [id., 2013], un’opera che segna uno scarto significativo con la produzione precedente di d’Agata, Aka Ana è un film girato sotto il segno dell’oscurità, dell’amore e della morte – dell’osceno.
L’osceno (o-skenè) è ciò che sta fuori dalla scena, irrappresentabile. I primi minuti di Aka Ana pongono esplicitamente la problematica dei limiti della rappresentazione, di cosa si può e cosa non si può filmare. Una voce femminile incalza il fotografo: «Non capisci il mondo. Lo divori, ecco tutto.» «Voglio raccontarti la storia di alcune ragazze.» Mentre la donna lo interroga, d’Agata inquadra se stesso riflesso davanti a uno specchio.
Fin dai primissimi minuti, Aka Ana si configura come un film-dialogo; la messa in discussione di un metodo di lavoro. Quali sono le responsabilità di d’Agata? L’autore, in Aka Ana, è testimone, voyeur, carnefice, oppure è sullo stesso piano delle ragazze filmate? Questi interrogativi sono da sempre il centro dell’opera del fotografo francese. Il fatto che la morale sia esclusa dal processo che presiede alla realizzazione del film non vuol dire che Aka Ana non ponga, alla fine della proiezione, brucianti questioni sulla responsabilità del metteur en scène. Al contrario, la componente autoriflessiva delle fotografie e dei film di d’Agata rappresenta uno degli aspetti più stimolanti della sua opera. La riflessione sul mestiere di produttore di immagini, e sul ruolo che tale mestiere assume nella società capitalistica contemporanea, è portata in Aka Ana su due strade distinte che dialogano continuamente (e, talvolta, contraddittoriamente) tra loro: l’immagine e la parola. L’immagine di Aka Ana ha una natura ibrida; lo stesso film è realizzato con materiali eterogenei. Vi sono sequenze in cui d’Agata, modificando il rapporto dello shutter della macchina da presa4, deforma le immagini, ricalcando l’effetto scia di alcune delle sue fotografie più famose. Il risultato è un’immagine volutamente grezza, impura e disturbante.
Nelle sequenze dal contenuto pornografico, invece, d’Agata utilizza effetti diversi, allontanandosi consapevolmente dall’estetica delle proprie fotografie: le immagini sono nitide, illuminate da luci rosse o viola. Gli amplessi si svolgono nell’oscurità, sui palchi, sotto luci stroboscopiche, oppure nelle camere da letto. Attraverso un découpage estremamente frammentario, tutto primissimi piani e décadrage, d’Agata, al contrario di un cineasta-fotografo patinato come Larry Clark, frustra la logica eccitativa dell’immagine pornografica: l’erotismo di Aka Ana è mortuario, folle, a tratti insostenibile. D’Agata registra, impassibile, e non fa niente per rendere consumabili le immagini del film.
Aka Ana, pertanto, si pone in una situazione di radicale alterità rispetto al circuito tradizionale di produzione delle immagini, rimanendo irriducibile a qualsivoglia logica commerciale. In questo senso, la pornografia di Aka Ana non compie un lavoro di mercificazione sui corpi ma piuttosto permette al regista di filmarli senza pregiudizi, per raccontare «un mondo senza Dio», un mondo, utilizzando nuovamente le parole di d’Agata, «dove non resta che la carne, l’organico, la materia»5. Disinteressato a una traduzione letterale di Bataille (d’altronde la letteratura dell’autore di Storia dell’occhio [1928] è nota per essere intraducibile filmicamente)6, d’Agata cerca di adattare le suggestioni di Madame Edwarda alle situazioni che, casualmente, gli offre la realtà. Aka Ana allora è un film significativo proprio perché testimonia il farsi di un lavoro il cui residuo – il rapporto d’amore che si costruisce sul set tra regista e attanti – è l’unica verità; una verità che però si offre allo spettatore indirettamente, come un mistero inaccessibile. Anche per questo, Aka Ana rappresenta un capitolo fondamentale del cosiddetto “cinema del reale”, quel cinema impossibile da catalogare che fa saltare il confine tra fiction e documentario, vero e falso. Dice d’Agata: «Nessuna di queste due posizioni sono per me esteticamente ed eticamente valide. L’unica posizione che mi interessa è mettere me stesso nel mondo reale, nella realtà, e provocarla, e decidere se distruggerla, cambiarla. Giocare con la realtà. Quello che mi interessa è la vita, questa posizione in cui tutto è possibile, niente è proibito e vietato.»7
Proprio perché ha dovuto accogliere nel proprio farsi gli imprevisti del reale, Aka Ana ha una struttura violentemente frammentaria. Le ragazze rimangono figure anonime, corpi fantasmatici a cui il film concede la parola solo indirettamente, nella forma di commento fuori campo. L’evanescenza delle ragazze, la loro inconsistenza come personaggi, è una delle ragioni per cui si accusa il lavoro di d’Agata come voyeurista e sensazionalista. In realtà, le donne in scena non sono le vittime di un regista carnefice ma sono le co-autrici dell’opera di d’Agata: in Aka Ana, sono proprio le prostitute – filmate come martiri – che raccontano il film. Le parole scritte e poi recitate in autonomia dalle ragazze tematizzano involontariamente la complessità di questo rapporto: sono parole poetiche, strazianti e disperate, che interpellano direttamente l’autore.
Lungo i suoi sessanta minuti di durata, Aka Ana pone lo spettatore di fronte a un paradosso: essere una storia d’amore insostenibile, impossibile da guardare e consumare. Il film di d’Agata rappresenta allora un capitolo importante della rappresentazione della sessualità al cinema. In Che cosa è il cinema?, André Bazin scrive che il sesso e l’amore non possono essere filmati: «Come la morte, l’amore si vive [corsivo del redattore] e non si rappresenta – non è senza ragione che lo si chiama la piccola morte – o almeno non lo si rappresenta senza violazione della sua natura. Questa violazione si chiama oscenità»8.
Aka Ana è un film che tematizza l’amore come l’osceno, come ciò che sta “fuori dalla scena” in una società capitalistica ipocrita e in via di dissoluzione; e lo fa presentando come ultima àncora di salvezza immagini non consumabili, che appunto significano l’impossibilità del cinema di rappresentare (e, dunque, mercificare) l’amore. A priori, pertanto, non potrà che esservi una distanza, uno scarto tra la prospettiva del regista e quella dello spettatore che vede, da fuori, il film, ed è proprio questa distanza che fa la forza politica e lo scandalo di Aka Ana. Per questo, non deve sorprendere che il regista descriva Aka Ana come una storia d’amore con protagoniste sette donne. Aka Ana è il racconto in soggettiva della relazione intima costruitasi, sul set, fra d’Agata e le ragazze del film, il documentario allucinato di questa relazione. Le donne, pertanto, non possono che apparirvi come fantasmi; non possono che parlare (in)direttamente al regista. È questo lo scandalo del cinema (e delle fotografie) di d’Agata: le sue immagini non sono nient’altro che uno specchio, un frammento di realtà; non dicono nessuna verità, eccetto quella, oscena (fuori-scena), del rapporto fantasmatico che lega l’autore e il mondo che in cui vive, ama, soffre e gode.
Note
1. Georges Bataille, Madame Edwarda (1956), trad.it. Luca Tognoli, Gremese, Milano, 2013, p.52. 2. «I prefer a bad photo of documenting my real interpretation to the world of a good photo than looking like a voyeur or useless witness.» Antoine d’Agata, in Manik Katyal, Depth Charger – Antoine d’Agata Part II, EMAHO Magazine,http://emahomagazine.com/2013/01/depth-charger-antoine-dagata-part-ii/,http://magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL53T_6. 3. «It’s not how a photographer looks at the world that is important. It’s their intimate relationship with it.» Antoine d’Agata, http://magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL53T_6. 4. Ringrazio Alberto Libera per la consulenza tecnica. 5. Antoine d’Agata, Note d’intention, http://gncr.fr/films-recommandes/aka-ana. 6. Il regista che più si è avvicinato a tradurre filmicamente Bataille è stato forse Philippe Grandrieux con White Epilepsy [id., 2012] e Meutrière [id., 2015]. 7. Antoine d’Agata, in Lorenzo Baldassari (a cura di), «Quello che mi interessa è la vita, questa posizione in cui tutto è possibile, niente è proibito»: Intervista con Antoine d’Agata, Lo Specchio Scuro, http://specchioscuro.it/interview-antoine-dagata-intervista-antoine-dagata. 8. André Bazin, Morte ogni pomeriggio (1949-51), in Id., Che cosa è il cinema?, Garzanti, Milano, 1973, p.32.
Recensione: specchioscuro.it