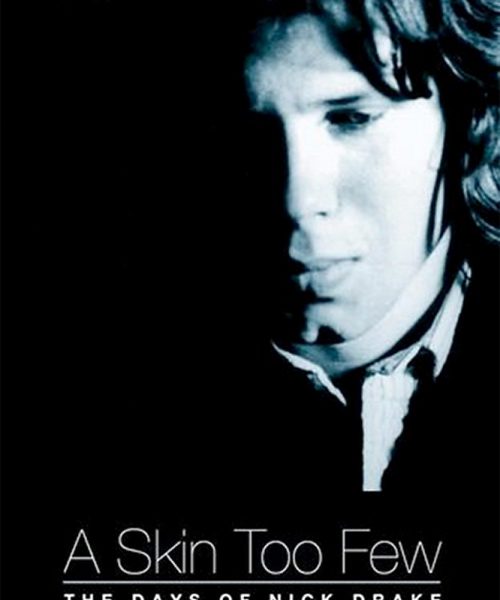Titolo originale: Caiyou riji
Nazionalità: Cina Olanda
Anno: 2008
Genere: Documentario
Durata: 840 min.
Regia: Wang Bing
Una giornata di lavoro quasi in tempo reale di alcuni lavoratori su una piattaforma petrolifera in mezzo al deserto nel distretto di Huatugou, nella provincia Qinghai nella Cina occidentale, dalla dormiveglia in attesa del lavoro in piena notte fino alle attività di estrazione portate avanti per ore e ore, dal riposo pomeridiano davanti a un film in una delle camere da letto degli operai fino alle ultime attività serali.
Lontano dalla famiglia di Oxhide (Cina, 2005, 110′) e Oxhide II (Cina, 2009, 133′) e lontano dalla città di Disorder (Cina, 2009, 58′), c’è un deserto e in questo deserto gli operai che vedremo assiepare le stazioni in Last train home (Canada/Cina/Inghilterra, 2009, 87′) lavorano all’estrazione del petrolio: vivono lì, fuori dal mondo come il tipo di Man with no name (Francia, 2009, 92′) ma, a differenza di quest’ultimo, quegli operai non sono esclusi da quel mondo e appaiono invece come sua colonna portante, come la spina dorsale che non si limita a tenere in piedi la Cina ma le dà pure un senso così come la colonna vertebrale dell’essere umano permette a quest’ultimo la stazione eretta e, con essa e di conseguenza a essa, un insieme di cose che evoluzionisticamente lo differenziano dai quadrupedi (il linguaggio, per esempio). Ora, questo senso è l’alienazione, e Crude oil (14 ore) è prima di tutto un film alienante sull’alienazione, poiché gli operai addetti all’estrazione del petrolio che riprende risultano quasi disarticolati dal sistema di produzione di cui fanno parte e, di più, appaiono come tagliati fuori dal mondo: lavorano, aspettano di lavorare o parlano di lavoro… ma non basta. Il lavoro, infatti, risulta dalla meccanicità di gesti apparentemente inutili ripetuti per delle ore e l’attesa di lavorare si risolve in un accartocciamento del proprio corpo sul pavimento vicino ad un armadio o su di una panchina scomodissima alla ricerca di una mezzora di sonno nel container dove qualcuno ascolta da una radiolina musica elettronica e altri si lamentano dello stipendio. Ci si chiederà, in maniera innocua e banale, se sia vita, questa, e con ogni probabilità non si centrerà il punto. È vita, questa? La domanda, appunto, non ha valore, è trascendente rispetto all’oggetto dell’interrogativo e, dunque, capziosa, perché è posta dall’esterno, da uno spettatore che vive in un mondo che non è quello, dove c’è, appunto, un mondo e dove il mondo non si risolve nella desolazione di un conglomerato industriale circondato dal deserto. Bisogna essere più umili, e Wang Bing ce ne dà la possibilità attraverso una forma solo apparentemente ipertrofica: girare un piano-sequenza a macchina fissa di oltre un’ora in cui è ripreso un uomo azionare una leva o un altro che abbia per oggetto un tizio semi-addormentato significa tentare di immanentizzare il cinema, convogliando lo spettatore sul medesimo piano dell’oggetto filmato. In questo senso, Crude oil non è un’installazione ma una pellicola che dev’essere fruita consecutivamente, in tutte le sue quattordici ore, perché solo così si esperirà l’alienazione di cui sono vittime quegli operai, e del resto c’è una consecutività, in Crude oil, un procedere che non è per nulla casuale ma che, anzi, segue cronologicamente una giornata lavorativa, ed è proprio questa cronologicità a permettere allo spettatore di entrare prima e di alienarsi poi in quel mondo, cosa che succederà, tra l’altro, anche in Feng ai – ‘till madness do us apart (Hong Kong, 2013, 227′). Qualcuno, a questo punto, chiederà «Che senso ha?», ma anche questa domanda è mal posta, oltre che estremamente capziosa, e lo è, appunto, perché Crude oil stende davvero un piano d’immanenza in cui spettatore e film sono (in) un’unica realtà che confonde l’esistenza e il cinema: in Crude oil, il cinema è l’esistenza e l’esistenza è nel cinema, sicché la domanda che chiede quale sia il senso della pellicola diventerà «Qual è il senso dell’esistenza?» e solo questa. Lo spettatore si aliena dalla sua realtà per far parte dell’inquadratura arrivando a coincidere con l’occhio della mdp così come l’operaio si aliena dalla propria, di realtà, attraverso un lavoro forsennato e forsennante che è sempre un vivere-per-lavorare e mai un lavorare-per-vivere, visto l’esclusione dal mondo dello stabilimento petrolifero e, conseguentemente, il diventare-mondo di questo stabilimento. Sia chiaro, non si tratta di un distretto industriale com’era per Tie Xi Qu: West of the tracks (Cina, 2003, 556′): qui non ci sono famiglie, qui le famiglie esistono solamente come idea, come puro ricordo, ed è questo il lato forsennato del lavoro, il fatto cioè di guadagnare per la famiglia di cui solo burocraticamente si fa parte ma dalla quale si è effettivamente ed affettivamente slegati. Esiste solo il lavoro, e per di più così standardizzato da risultare come un che di ritualistico, quindi eminentemente cultuale, ma di una cultualità che finisce presto per identificare l’uomo con la macchina, depersonizzando l’uomo e personalizzandolo come uomo-macchina (esemplificativi, a questo proposito, i campi lunghi in cui gli operai sono ripresi dentro la macchina, pressoché con-fusi con essa e in essa). Si capirà bene, giunti a questo punto, come l’epocalità di Crude oil, paragonabile forse soltanto a quella di Karamay (Cina, 2010, 356′), almeno nell’ambito della new wave documentarista cinese, risieda tutta qui, tant’è che il film, per la sua portata eversiva, ha lo stesso peso della scoperta dell’inconscio da parte di Freud, con la differenza che lo psicanalista ha poi tentato di edipizzare l’inconscio, svuotandolo di tutta la sua potenza, mentre invece Wang Bing, nelle opere successive, non farà che esprimere la potenza del cinema scoperta con Crude oil. Insomma, è una questione di potenza, e forse la domanda baziniana andrebbe riformulata, perché insufficiente a cogliere la specificità e la differenza del cinema dalle altre arti e di un film dall’altro: non «Cos’è il cinema?» bensì «Cosa può il cinema?». Ecco, credo che solo sulla base di questo interrogativo ci si debba approcciare a una pellicola, poiché solamente così si coglie la sua specificità e solo così il film può essere valutato. «Cos’è il cinema», del resto, è una domanda vuota, che tenta di astrarre da ogni singolo film quell’essenza invisibile che si manifesta a ognuno in maniera differente a seconda delle abitudini, del background culturale, della società e dell’educazione di ognuno e che, dunque, non può che rimanere aporetica; purtroppo, però, ci si è abituati con troppa facilità ad un regime cinematografico che non può nulla, prima di tutto sui nostri corpi, e dicendo questo penso non solo all’industria hollywoodiana ma a quanti ancora vanno sostenendo che il cinema sia intrattenimento o, peggio ancora, arte, estetica, solluchero visivo, e non si rendono mai conto di parlare della mediocrità dell’arte borghese dall’alto della loro mediocre vita borghese (non è vero, Arwen Lynch?), la quale non vuole essere scalfita ma autenticata, obliterata da cose come questa letteratura sempre più scadente, quest’arte sempre più interessata alle proprie quotazioni finanziarie, questo cinema sempre più innocuo. Al contrario, il cinema di Wang Bing, che pure – sia chiaro – ricerca un equilibrio formale attraverso geometrie degne del miglior Tsai Ming-liang (quello di Stray dogs (Taiwan, 2013, 138′) e Goodbye, Dragon Inn (Taiwan, 2003, 82’), per intenderci) e capaci di trasfigurare un’inquadratura in un vero e proprio dipinto, si definisce per ciò che può e, a fortiori, per ciò che riesce a fare, e come tale sussiste al confine, in quelle lande remote che pochi hanno il coraggio e la voglia di visitare. Il coraggio e la voglia, sottolineo.
Perché di coraggio e voglia si tratta: Crude oil è un film per tutti, di cui chiunque può fruire nonostante il suo background culturale e sociale, a differenza, chessò, di un film di Zalone, che è molto più elitario perché solo in pochi – solo una determinata cerchia di persone cresciute in un determinato ambiente ed educati a determinati valori – possono avervi accesso, possono per così dire capirlo (l’eschimese o il bambino del Bengala di certo non potrà capirlo, per dire). Il coraggio e la voglia, appunto, perché è facile rimanere nel proprio territorio e ignorare gli altri popoli ed è conveniente vivere l’Altro come il nostro peggior nemico: il cinema è questo, Hollywood – è palese – fa questo, produce un intrattenimento che è fittizio, ma è proprio questo suo carattere finto che ci ammalia, perché rende più vera la nostra esistenza, e voi non vi accorgete che la vostra esistenza è ontologicamente ridicola perché non vera ma più vera della finzione, quindi iper-finta, inconscia della propria intrinseca finzione. Siete delle maschere teatrali, e più il vostro personaggio è un buffone più vi sentite meglio, più vi divertite: «Combatti la finzione con la finzione», scriveva Leyner. Certo, mi rendo conto che questa è una prospettiva volta alla rassegnazione, un discorso che inevitabilmente porta a restare soli, ma questa solitudine non è che una destituzione dall’irreale e dalla finzione – destituzione quindi necessaria per autenticarsi come necessarie sono le destituzioni dell’immagine che sia Wang che Tarr operano nei finali – rispettivamente – di Crude oil e de Il cavallo di Torino (Ungheria, 2011, 146′). Ecco la potenza del cinema, ecco cosa può il cinema – e sta qui, Giorgia, il suo potenziale eversivo. Si tratta di etica, non di morale. Non c’è un giusto e uno sbagliato, ma semplicemente un «Cosa posso fare, dove posso arrivare, come posso essere felice e diventare ciò che sono». Altrimenti, sprechiamo tutte le nostre occasioni e non soltanto rimaniamo nell’impermanente ma soggiacciamo pure all’inautentico, e se qualcuno pensa che all’impermanenza siamo condannati è perché muore inautentico, ma in realtà possiamo farci eterni e arrivare quasi a esperire il fatto che sul nostro corpo si siano inscritte tutte le tragedie del mondo, tutte le civiltà del mondo, per le quali ora esistiamo. Non si tratta di essere degli hooligan, markx, ma di non essere così egocentrici da riuscire a pensare a cosa cazzo gliene freghi agli altri di quello che penso io su quanto sia convincente la trama dell’ultimo film di Spielberg, di tenere alla persona altrui, di essere così umanisti da rammaricarsi se MacGuffin perde tempo con Godzilla (USA, 2014, 123′) quando può esperire l’eternità, viste (non solo) le sue predilezioni cinematografiche. È come innamorarsi: ci si innamora di una persona perché non si può più amare la persona con cui si è rotto precedentemente, ma questo secondo amore è un amore inautentico, che, sì, farà uscire dalla solitudine di un amore altrimenti autoreferenziale ma che, di fatto, fa sentire ancora più soli di quanto non ci si senta se si vivesse in compagnia – e nell’autenticità – di se stessi e del proprio desiderio. Ecco, Crude oil dà sostanzialmente questa possibilità, ed è magnifica la grazia con cui riesce a farlo: capolavoro ieratico e contemplativo, Crude oil è la solitudine ed è l’alienazione, ma c’è qualcosa di catartico in tutto questo, qualcosa che spinge a svincolarsi dall’inautentico per entrare definitivamente nelle nostre esistenze. È un discorso che inevitabilmente porta a restare soli? Senz’altro, ma si può essere soli in compagnia, come io lo sono con ViS, come lo si è in una sala cinematografica.
Recensione: emergeredelpossibile.blogspot.it

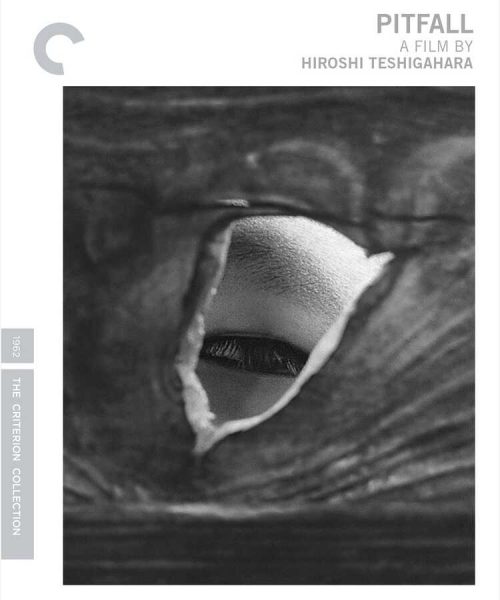
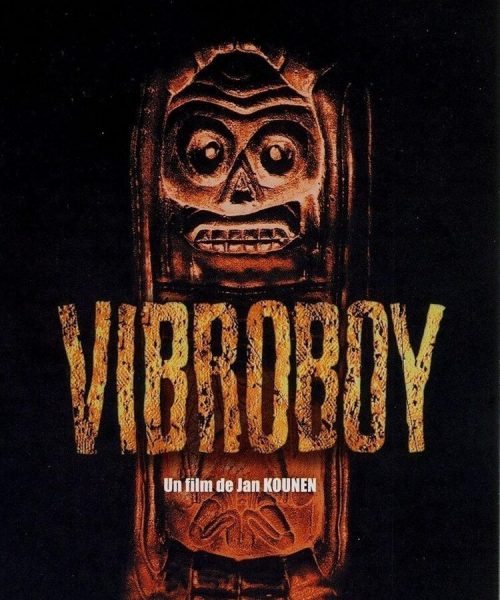


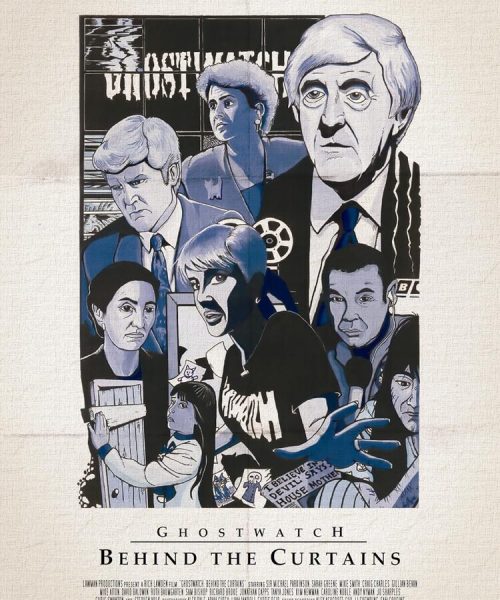
![LATE NIGHT WITH THE DEVIL [SubITA]](https://filmperevolvere.org/wp-content/uploads/2024/04/ezgif-2-3e43af5fb6-500x600.jpg)
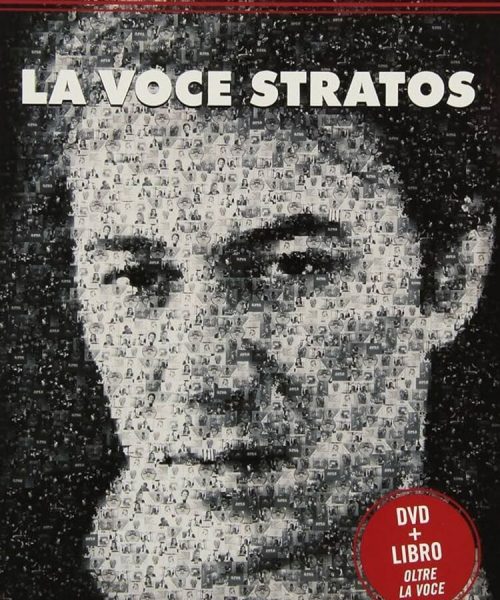
![HUNDREDS OF BEAVERS [SubITA]](https://filmperevolvere.org/wp-content/uploads/2024/04/ezgif-4-c6cd7d1f9b-500x600.jpg)