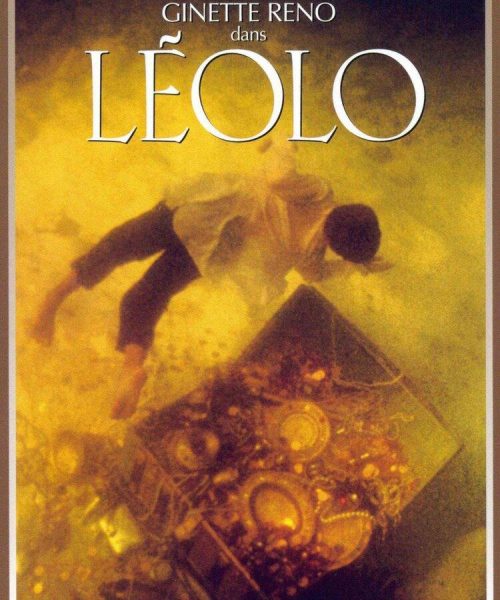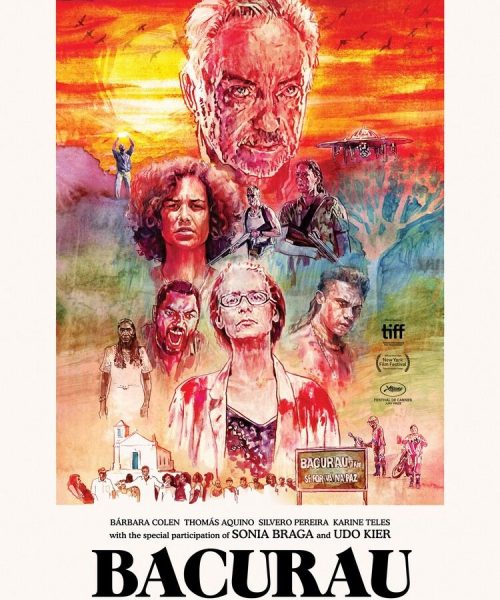Titolo originale: Hikari
Nazionalità: Giappone
Anno: 2017
Genere: Drammatico, Sentimentale
Durata: 101 min.
Regia: Naomi Kawase
Post tenebras lux
Misako ama descrivere gli oggetti, i sentimenti e il mondo che la circonda. Il suo mestiere di descrittrice audio di film è tutta la sua vita. Fuori da una proiezione, incontra un celebre fotografo la cui vista si sta deteriorando in modo irreparabile. Nascono dei sentimenti forti tra un uomo che perde la luce e una donna che la ricerca.
Radiance, splendore. La luce è un elemento da sempre fondamentale all’interno del cinema di Naomi Kawase, come ogni aspetto della natura, matrigna e benigna allo stesso tempo, luogo in cui è necessario perdersi per ritrovarsi, lasciarsi inglobare in un universo altro, difforme dal reale ma non per questo meno tangibile e persistente nella memoria. È scomparso il padre della protagonista Misako, che si è perduto nei boschi (quante suggestioni e cortocircuiti sulla Croisette implica questa scelta, visto che dopodomani passerà in una non-anteprima Twin Peaks di David Lynch…) e non ne è mai riemerso; è scomparso e ha lasciato dietro di sé il lutto, la nostalgia di un affetto che non è più tangibile, non è più dimostrabile, non ha più una sua rappresentazione nella vita quotidiana. Il lutto. La memoria. La perdita. La riappropriazione di sé. I temi centrali attorno ai quali ruota l’intera esperienza da cineasta di Naomi Kawase sono tutti presenti in Hikari, vale a dire Radiance, il film che riporta in concorso a Cannes la regista giapponese a tre anni di distanza da Still the Water – con il quale affermò alla stampa nazionale dell’arcipelago di voler vincere il festival, fallendo nel tentativo – e a due dal poco convincente An, uscito nelle sale italiane con il titolo Le ricette della Signora Toku, discutibile frullato mainstream della sua poetica espressiva.
Per quanto sia stato accolto con un certo entusiasmo alla proiezione stampa mattutina a Cannes, Radiance non è certo un film facile; in molti hanno già preso le distanze da questa storia di ricerca di sé e dell’altro, attribuendo alla Kawase un’insincerità che in tutta franchezza non alberga né in questo né nella stragrande maggioranza dei suoi lavori precedenti. Regista che non teme l’estasi visiva e il palesamento anche esasperato della metafora, Naomi Kawase si muove su territori paludosi, come Misako che si infanga le scarpe per cercare di percorrere il sentiero in salita che dovrebbe portarla al tramonto oltre le montagne, e alla madre.
No, non è un film facile questo Radiance, che stratifica il discorso muovendolo in direzioni sia corali che singole: c’è la storia d’attrazione/amore tra Misako e Masaya, c’è il riannodarsi della storia personale della ragazza e dell’illacrimata sepoltura, c’è soprattutto il discorso teorico sull’immagine, veicolo delle umane derive anche quando è assente, o non è possibile vederla. La cecità che sta trascinando nel mondo delle ombre Masaya è allo stesso tempo un concetto concreto – e narrativamente rilevante – e astratto; Misako, audio-narratrice che racconta i film a chi non è in grado di vederli con i propri occhi, è la risposta a una solitudine che diventerà presto gabbia dalla quale sarà impossibile evadere. Per quanto la teoria si faccia sempre più persistente, con Radiance che diventa pamphlet sulla potenza riparatrice del cinema, sulla sua capacità di ricongiungere i fili spezzati e di donare nuova forza alle relazioni umane (e nell’incipit coesistono in maniera naturale tanto la fruizione del cinema quanto la sua realizzazione, con una persona che fa l’ingresso in sala armato a sua volta di videocamera), sarebbe riduttivo fermarsi a questo aspetto. La teoria per la Kawase non può mai esulare dal deflagrare di un umanesimo carico di umori e vitale, vivo, pulsante.
Così prende corpo il rapporto tra due figure debilitate, menomate l’una nella psiche l’altro nel fisico. In quel racconto incessante del film che dovrà essere proiettato – Misako è ‘testata’ da un gruppo di lavoro, del quale fa parte anche Masaya, per vedere se è in grado di raccontare il film a chi non ha il dono della vista – si muove la ricerca di un punto comune in cui gli esseri umani possano trovare una posizione paritaria, nonostante tutto e tutti. Un utopico ma reale e credibile slancio dialettico, elogio della condivisione che è anche inno all’empatia, alla capacità di comprendere l’altro da sé e rimettersi completamente nelle sue mani. La luce come ideale da rincorrere, anche quando non si percepiscono altro che ombre, silhouette dell’umano. La luce della sala o del sole come argine all’inabissamento nel sottobosco, alla sparizione.
Come molti altri film presentati in concorso nella settantesima edizione del Festival di Cannes (da Happy End di Michael Haneke fino a The Day After di Hong Sangsoo) anche Radiance sembra a tratti un compendio della carriera della regista: si va da Suzaku a Hanezu, fino ad arrivare a Mogari no mori, del quale Radiance appare come una vera e propria prosecuzione, o quantomeno come una deviazione sul medesimo tracciato. Nell’affermare questo non si deve però far scattare l’automatismo che vuole questo come film minore in quanto “non nuovo”: è semmai da apprezzare la volontà della Kawase di saper rintracciare i germi fondativi del suo approccio alla regia – a partire dalla capacità di mettere in scena l’atto creativo e distruttivo della vita senza ricorrere a cliché abusati e senza scadere mai nella retorica spicciola – e di reinventarli, costringersi a vederli sotto ulteriori prospettive.
Un cinema fortemente espressivo ed emotivo, mai distante dalle figure che mette in scena ma partecipe, grondante gli stessi umori dei suoi personaggi, nel bene e nel male. Una visione teorica e viscerale al contempo, ectoplasmatica e romantica, che narra il perdersi dell’umanità in una selva oscura, e il desiderio di ritrovare o trovare per la prima volta la retta via.
Recensione: quinlan.it