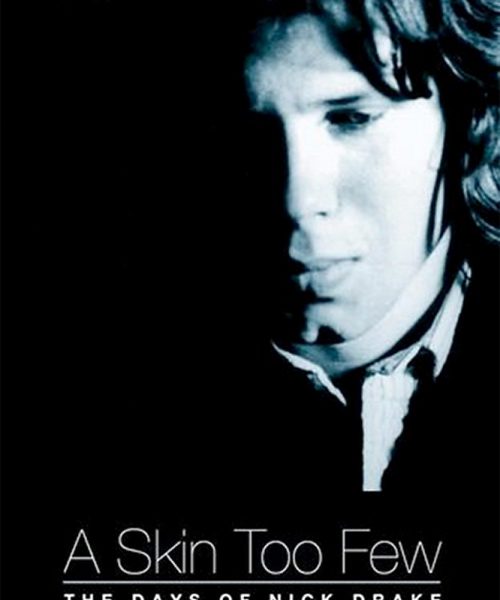Titolo originale: L’Apollonide – Souvenirs de la maison close
Nazionalità: Francia
Anno: 2011
Genere: Drammatico, Erotico
Durata: 125 min.
Regia: Bertrand Bonello
Un consesso di fantasmi. È questo L’Apollonide. Souvenirs de la maison close. Un coacervo di desideri in un interno. Desideri dominanti, quelli dei clienti. Desideri residuali – annichiliti, frustrati, marginali – quelli delle donne di piacere.
E non serve conoscere Laura Mulvey, non serve appellarsi a modelli femministi o post-coloniali per rendersene conto: L’Apollonide (come il feroce Lola Montes di Abdellatif Kechiche: Venera nera) fa esperire allo spettatore la vertigine con cui lo sguardo della classe borghese riscrive i corpi, la tacita violenza con cui li deforma al proprio piacere, lo stupro con cui riduce identità altre alla proiezione di sé, all’ immagine del proprio volere. Corpi ridotti a fantasmi. Tra le mura dell’Apollonide il corpo è oggetto di negoziazione, adempie alla forma del desiderio, è una merce. Ma il nesso tra capitale e carne (si veda il controllo ginecologico: sostanzialmente un controllo qualità) e il Potere dello sguardo sono dati che non riassumono il quinto lungometraggio di Bonello. Che gira, in primis, un film su un luogo: l’Apollonide, un bordello a cavallo del 900. Organizzando in immagini uno studio di sociologia del quotidiano, un accumulo filologico di dettagli, abitudini, riti: la maison close è luogo di socialità per il potere, necessario territorio osceno per sfogare quello che la scena borghese nega per contratto sociale (dalla perversione sessuale alla malattia, vedi le sorti di Julie/Jasmine Trinca). Eppure i souvenirs, i ricordi della casa chiusa, sono quelli rappresi nei gesti di chi vi ha abitato, delle cause primarie e necessarie: le prostitute. Bonello opta per scelte oculate, scardinanti. Sceglie, rigorosamente contro le attese del pubblico, di non mostrare gli atti sessuale: perché è interessato al teatro posticcio della seduzione, alla danza erotica, al gioco dei fantasmi, ancora, prima che alla meccanica. Non appaga il prurito vouyerista, lo ripiega su se stesso, lo riflette e capovolge. E sceglie, dunque, il punto di vista delle ragazze: ne descrive con minuzia i gesti usuali, le segue nel retroscena dello spettacolo sociale (il salotto) e sessuale (le camere), dà forma ai loro sogni, restituendo loro una soggettività negata, invitando lo spettatore a una comprensione che sfugga ai luoghi della messa in scena, al teatro del potere, (sof)fermando il tempo sui minimi particolari, proiettando le andate e i ritorni della loro anima, articolando e perdendosi nelle memorie, negli onirici squarci di futuro.
La preservazione dell’irriducibilità identitaria di cui Baratti dice mirabilmente nella recensione di Quelque chose d’organique non sfocia nel relativismo. È l’esposizione al quotidiano, alla sua ripetitività, ai micromovimenti e alla banalità delle parole a dire dell’essenza delle protagoniste. Non ci sono psicologismi, perché le etichette non possono che essere brutali: non solo nell’umiliazione della performance sessuale, nei soprannomi feticistici affibiati alle prostitute, ma anche nella pseudoscientificità del saggio antropologico di Pauline Tornowsky, nella pretesa di fare dell’uomo (della donna) materia d’archivio, oggetto di catalogazione. Eppure la maison rimane una prigione, un luogo di non libertà, che Bonello fotografa con precisione: perché le abitanti non vedono la luce dell’esterno, perché i debiti le incatenano, perché, soprattutto, il loro magro orizzonte è socialmente coatto, cieco, aperto all’unico miraggio di un benessere insperato, di un riscatto (letterale) da parte di un signore che le salvi, che le compri, che (non) le liberi. Si soffoca, in L’Apollonide, filmcervello che coincide con un ambiente da cui è quasi impossibile uscire, sinapsi che sono porte e corridoi, neuroni che sono corpi di donne in vendita. Un immaginario chiuso, un film (dunque) circolare, che entra in loop, reitera momenti, cambia prospettive, ricontestualizza i propri frammenti, modula solo variazioni interne («La ripetizione – ricorda citando Brian Eno – è una forma di cambiamento»). Così l’epilogo contemporaneo, tra le prostitute della periferia di Parigi, rappresenta il risveglio da quel sonno in cui Clotilde/Céline Salette dice di volere sprofondare, è l’abiura all’incertezza con cui questa risponde alla domanda: «Cosa farai ora?». E così l’amoroso sogno di riscatto di Madeleine/Alice Bernol, recitato in apertura, si invera, crudelmente, nel dolorosissimo finale, catarsi umiliata, liberazione consapevole dei propri limiti: lei indossa una maschera neutra, si sottrae al suo essere monstro, figura sfigurata, viene scelta da un cliente, si proclama se stessa («Come ti chiami?» «Madeleine» «Non hai un soprannome?» «No»), gode. Piange sperma, come se il suo corpo sapesse di non poter essere che contenitore di seme. Contemporaneamente il colpevole delle sevizie su Madeleine, mascherato, ha un rapporto con Samira/Hafsia Herzi (a cui l’amante abituale ha regalato uno smeraldo con la promessa di saldare i suoi debiti). Lei, accortasi dell’identità dell’uomo, esce dalla camera, vi accompagna una pantera, lascia che lo sbrani. Mentre tutte le prostitute, con il volto sfigurato dal trucco, mascherate da Madeleine, guardano attraverso uno specchio. Semplicemente. Una questione di lotta di classe: la solidarietà tra le donne non è solamente in questo gesto di vendetta, non è solamente nel reciproco, fisico aiuto quotidiano, ma anche nella previsione di Madeleine, il cui sogno si fa realtà condivisa (dal gruppo, in maschera come nelle immagini oniriche, e da Samira, che si libera): perché quando leggono le carte, in fondo, chiedono di conoscere il destino di tutte. E la violenza catartica della nemesi, non è, ovviamente, nella distruzione del corpo dell’uomo sopraffattore, che Bonello non ci mostra, ma nello scacco dell’atto di vedere, nella rivalsa dei fantasmi: le donne si fanno immagini caricaturali del volere dell’oppressore, in una mascherata che è una riappriaproziane conscia, e da oggetto si fanno soggetto scopico, danno forma al loro desiderio.
Così L’Apollonide si configura sfacciatamente come un’opera sul cinema: ambientata sul finire dell’800, all’alba del cinematografo, strutturata intorno a scene (sociali) in cui recitare, incentrata sui rapporti di potere impliciti nello sguardo, esplicita la sua vocazione nello smaccato casting: i corpi delle donne sono negoziati da interpreti che, nella vita, lavorano come cineasti. Così Noémie Lvovsky è la padrona/regista dell’Apollonide (e in una scena sottopone Pauline/Iliana Zabeth a un provino), Xavier Beauvois, Jacques Nolot, Pierre Léon e Damien Odoul sono i clienti a cui i corpi mercificati si conformano, Pascale Ferran è la voce over che pronuncia le sentenze del libro di Pauline Tornowsky. Ed è un invito. Ed è una sfida. L’obiettivo: un cinema fuori dagli schemi, che rifletta e poi si emancipi dalle strutture che ingabbiano il vedere. Così L’Apollonide è esatto nella ricostruzione e insieme capace di estraniarsene, in grado di restituire identità ai personaggi e abbracciarli in un unico corpo sognante, in un terribile fine collettivo. E mentre fonde le soggettive visive, mentali, acustiche, il film s’inerpica di fronte ai nostri occhi, rizomatico e sprezzante (musiche contemporanee tra costumi d’epoca), nello spazio e nel tempo, nei corpi e nelle menti. Come un film di Claire Denis, con la stessa capacità di destrutturare lo sguardo, di imboccare strade perdute. E con l’attitudine al quotidiano e all’essenziale di un Phillippe Garrel. E non solo: oltre ai sorprendenti riferimenti citati nella sezione ipse dixit, oltre al Victor Hugo mediato da L’uomo che ride e Black Dahlia, è evidente l’influenza di Lynch (gli oggetti come chiavi di porte mentali, il trattamento di certi momenti della colonna sonora, firmata dallo stesso Bonello), la rielaborazione di atmosfere kubrickiane (Eyes Wide Shut), e, soprattutto, la presenza costante di Joao Cesar Monteiro, parafrasato nel titolo (I ricordi della casa gialla) e aleggiante sottotraccia.
Eppure quella di Bonello è cinefilia liquida, mai raggrumata in citazioni, ulteriore segno di un’encomiabile libertà compositiva: che qui, a differenza degli sfuggenti, fieramente (meravigliosamente) imperfetti Le pornographe, Tiresia e De la guerre, si muove tentacolare verso una chiusura narrativa, verso la composizione di un mosaico compiuto, come in Quelque chose d’organique. Alla dispersione preferisce la concentrazione, L’Apollonide. E regala un cinema di abbacinante bellezza formale, sensibile all’individuo nella coralità della narrazione, patetico nel senso migliore perché percorso da un raro, ostinato romanticismo, che trattiene il mélo nelle sue geometrie ma si fa indubitabile atto d’amore. È un’opera umanista, L’Apollonide, perché comprende i limiti dell’uomo, del mondo, della Storia, s’apre all’inferenza dello spettatore, sposa un punto di vista marginale e decostruisce il dominante, si fa raffinato e dolente gesto politico. Ed è un’opera coraggiosa, perché alla ricerca di soluzioni etiche e estetiche che non conoscano calcificazioni, frutto di un’idea di arte dello sguardo in perenne movimento, che riflette sull’essenza del cinema, sull’occhio e sul desiderio, e, mai paga, si sfida continuamente, comprendendo lo stato della settima arte e lo spirito del tempo, dissestandoli mentre li cattura, insieme a quelle identità che coglie e libera, nel paradosso di dover inquadrare quel che capisce di non poter fermare, ma solo restituire, accennare, evocare. Fanno questo, oggi, quelli che chiamiamo capolavori.
Recensione: spietati.it

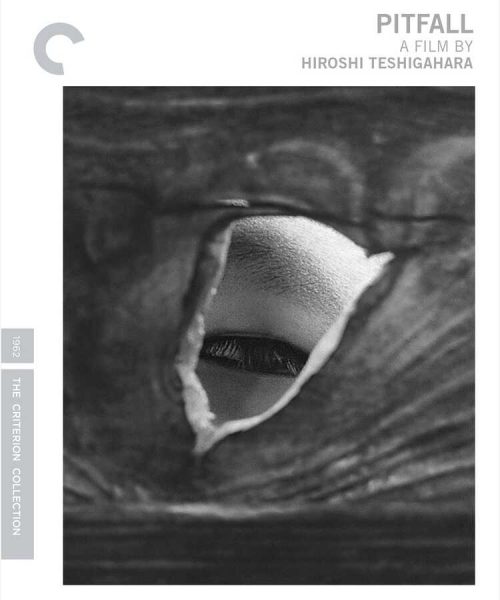
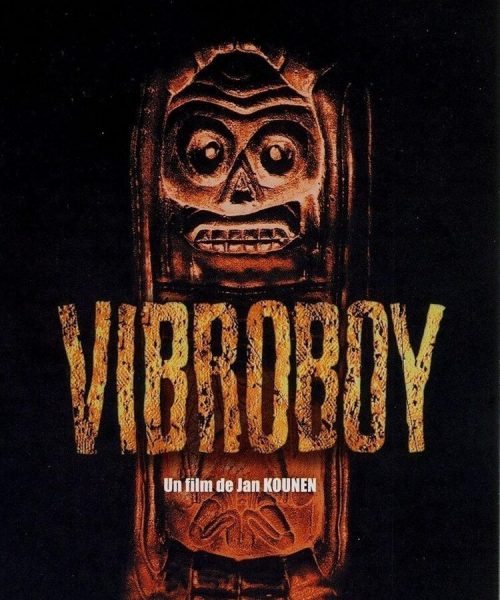


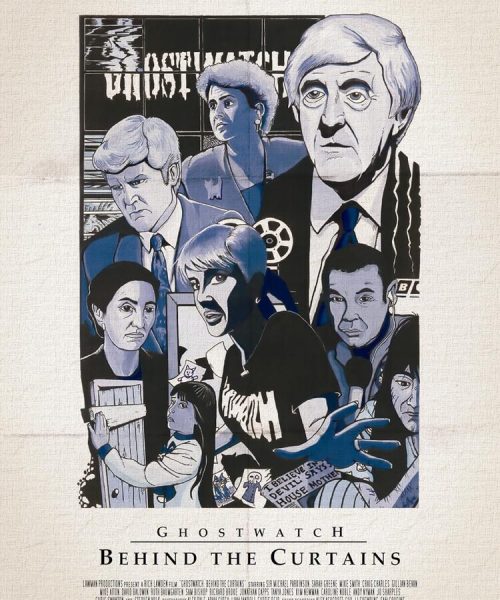
![LATE NIGHT WITH THE DEVIL [SubITA]](https://filmperevolvere.org/wp-content/uploads/2024/04/ezgif-2-3e43af5fb6-500x600.jpg)
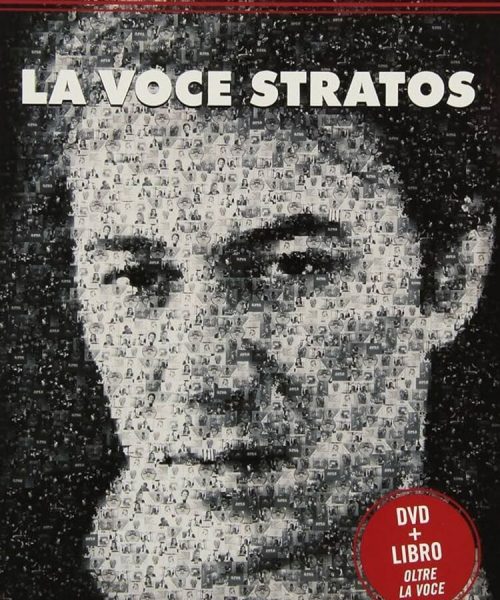
![HUNDREDS OF BEAVERS [SubITA]](https://filmperevolvere.org/wp-content/uploads/2024/04/ezgif-4-c6cd7d1f9b-500x600.jpg)