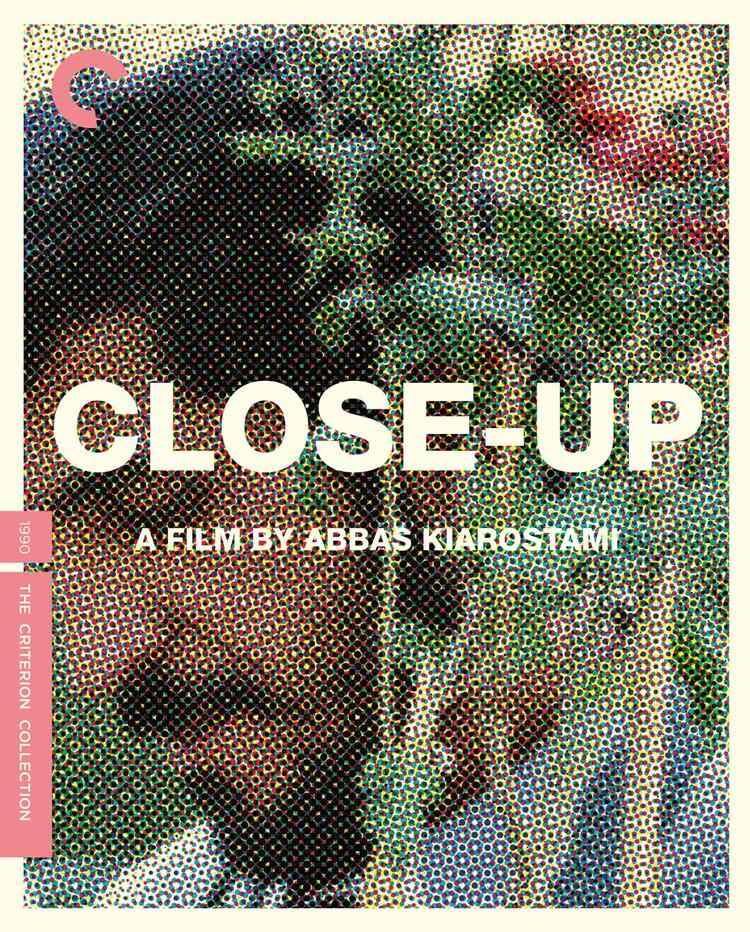
Titolo originale: Nema-ye Nazdik
Paese di produzione: Iran
Anno: 1990
Durata: 98 min.
Genere: Biografico, Thriller, Drammatico
Regia: Abbas Kiarostami
Capolavoro della seconda nouvelle vague del cinema iraniano, Close Up vede protagonisti i due autori simbolo di quella corrente. Abbas Kiarostami che è regista e Mohsen Makhmalbaf, che è il motore ultimo del film, comparendo anche brevemente. Un film che racconta della grande passione per la settima arte in un paese stremato da una lunga guerra, un’opera teorica e al contempo foriera di messaggi pacifisti, da un paese dall’antica cultura.
Il sapore del cinema
Hossein Sabzian, un giovane disoccupato amante del cinema, riesce a introdursi presso una famiglia benestante, facendosi passare per il noto regista Moshen Makhmalbaf e millantando un progetto cinematografico, per un film di cui quella famiglia dovrà essere protagonista. Quando l’inganno viene scoperto, Hossein finisce in tribunale. [sinossi]
«Una riflessione sul potere del cinema»: così Nanni Moretti definisce Close Up (il titolo originale in lingua farsi è traslitterato come Nema-ye Nazdik, mentre il titolo internazionale Close-Up porta il trattino, mancante invece nel titolo della versione distribuita in Italia) redarguendo la cassiera del cinema Nuovo Sacher, che non sapeva come definire il film a chi chiedeva informazioni al telefono, nel cortometraggio Il giorno della prima di Close Up. Moretti è stato uno dei principali artefici della diffusione italiana, negli anni Novanta, del cinema iraniano nel momento in cui questo attraversava un periodo di grande splendore, nella cosiddetta seconda nouvelle vague, quella post-rivoluzionaria, i cui massimi esponenti sono stati Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmalbaf. Entrambi hanno fatto opere autoriflessive sul cinema, sul fare cinema, e sui rapporti tra finzione e realtà. Il primo con la trilogia di Koker, con i film costruiti ciascuno sul precedente, il secondo con opere quali Once Upon a Time, Cinema, Hello Cinema e Pane e fiore, spesso esibendo anche la ricostruzione di episodi presi dalla realtà, a volte con gli stessi protagonisti chiamati a impersonare se stessi.
Qual è quello strapotere del cinema di cui parla Moretti a proposito di Close Up? Si tratta anzitutto di quella forma di condizionamento che ha spinto un cinefilo, che vive di cinema, a immedesimarsi in un popolare regista. Ma è anche il potere di far anticipare il processo per poterlo riprendere, e probabilmente di influire nella sua sentenza per la presenza delle cineprese in aula. L’evento di cronaca, determinato dal cinema, influisce ancora sul lavoro del regista Abbas Kiarostami che, venuto a sapere dell’accaduto, sente l’urgenza di filmare questa situazione abbandonando il progetto cui stava lavorando. Il paradosso è che l’amore per il cinema di Sabzian, che ama in particolare The Cyclist e Marriage of the Blessed di Makhmalbaf, non riguarda una fabbrica dei sogni hollywoodiana (che in Iran si poteva vedere all’epoca dello scià come nei ricordi nostalgici del vecchio personaggio di Pane e fiore), ma un cinema neorealista, a carattere sociale. Il cinema è molto popolare proprio perché rispecchia la realtà. Più battute dello stesso Sabzian ci portano a questa evidenza.
Nello stesso Close Up il discorso sociale è molto forte. Trapela una crisi generale per buona parte dei personaggi: il protagonista è disoccupato, l’autista del taxi all’inizio è un pilota d’aviazione in ritiro, i figli della famiglia borghese, che vive in una casa molto elegante, pur laureati fanno lavori di ripiego, uno di loro vende il pane anche se la madre bigotta precisa che dirige una grande panetteria. Sabzian in effetti ha capito benissimo il senso del cinema iraniano di osservazione sociale. Quando per la prima volta si spaccia per il celebre regista con la signora che incontra sull’autobus, e questa gli chiede come mai usi i mezzi pubblici, lui risponde dicendo che vuole mescolarsi alla gente per cercare soggetti da raccontare. Il gioco di Sabzian è sottilissimo, muovendosi tra immedesimazione e mimesi. Quando parla al processo è come se enunciasse un principio del lavoro dell’attore da Strasberg, ancora un paradosso perché parliamo di un cinema che usa spesso attori non professionisti, gente presa dalla strada. Fa dei lunghi monologhi anche citando Tolstoj in merito al senso dell’esperienza artistica. Sabzian è un attore che ha interpretato il ruolo di un regista. Al processo uno dei figli lo accusa di stare ancora recitando. E in effetti la magia di Kiarostami, e del cinema, è proprio quella di realizzare il suo sogno e di farlo entrare in un film. Al processo Sabzian, rivolto a Kiarostami, lo qualifica come il suo spettatore.
Il cinema quindi interferisce nella realtà che a sua volta ispira il cinema. Tutto Close Up si gioca su un filo labilissimo tra ricostruzione e ripresa reale. Difficile distinguere tra le due ed evidentemente nel cinema di Kiarostami i due approcci si equivalgono. Il film comincia con una ripresa che sembra rubata, i protagonisti che escono dalla caserma ripresi dal lato opposto della strada, coperti spesso dalle macchine di passaggio. Ma tutto quello che si rivela poi come il prologo, l’arresto di Sabzian, è evidentemente una costruzione cinematografica, con un montaggio, vari piani di ripresa. Eppure Kiarostami vuole dare il senso del tempo reale, tenendoci fuori dalla casa dove sta avvenendo la cattura da parte delle guardie e con tutta una serie di tempi vuoti, il giornalista che raccoglie fiori e che prende a calci una bomboletta spray facendola rotolare. L’episodio verrà successivamente mostrato anche dal punto di vista, solo, interno come uno dei flashback del processo in cui avviene la ricostruzione dei fatti. Qualsiasi regista avrebbe costruito un’unica scena su due piani paralleli, lavorando con il montaggio e tagliando i momenti vuoti. L’ultima scena, l’incontro di Sabzian, che esce di prigione, con il vero Makhmalbaf, e il loro viaggio in moto verso la casa della famiglia, è tutta composta di scene come rubate, riprese da grande distanza, con l’audio che si presume catturato da un microfono nascosto. L’audio viene e va: il tecnico audio di Kiarostami avrebbe poi rivelato che non sarebbe stato possibile tecnicamente. Ma l’illusione di spontaneità di tutta questa parte si infrange quando alla fine c’è uno stacco sul volto di Sabzian, un close up, dallo sguardo contrito, ultima immagine del film che sancisce il perdono e la pacificazione (ancora da confrontare con il finale di Pane e fiore anche per quel senso pacifista, messaggio in una società appena uscita da una rivoluzione e da una lunga guerra). Significa quindi che una mdp è collocata davanti all’uomo, e la ripresa quindi non può essere a sua insaputa.
Il close up, il dettaglio ravvicinato, appare un elemento estraneo allo stile di Kiarostami, propenso ai long take e con un approccio neorealista. Il significato è quello spiegato dallo stesso regista a Sabzian, quando gli illustra come riprenderà il processo (parte che Nanni Moretti identifica come un 16mm gonfiato in 35): due camere, una delle quali ha le lenti adatte al close up, con un fuoco stretto, l’altra con grandangolo, la prima per concentrarsi sul suo volto, la seconda per le riprese d’insieme della corte. Si sa che al cinema un attore può mostrare la sua bravura quando è ripreso in primo piano. La parte del processo, quella che siamo sicuri essere reale, è anticipata ironicamente da un ciak, e sostanzialmente è tutta giocata su due sguardi, uno verso l’imputato e i testimoni, l’altro verso il giudice. Una terza inquadratura mostrerà la troupe con attrezzatura, mentre in precedenza, durante l’intervista ai militari, si vede sporgere il microfono, cosa peraltro facilitata dall’aspect ratio 1,33:1. Altro close up su Sabzian si ha nel suo primo incontro con il regista in carcere, in un momento che appare come di direct cinema: ripreso da una finestra, con Kiarostami alle spalle, ingrandendo sul volto del detenuto. In genere comunque il regista non entra nell’inquadratura, le interviste sono con la sua voce fuori campo, come fossero sue soggettive.
Sembra difficile immaginare che anche con la sharia, la legge islamica in vigore in Iran, si possa dare tanto credito a un reato irrisorio come quello di cui si è macchiato Sabzian. La frode, dal punto di vista pecuniario, è consistita solo nei soldi di una corsa di taxi. Quello che interessa a Kiarostami è ovviamente il millantare dell’uomo, la sua suggestione. Il processo sembra un momento infantile come quelli che il regista coglie quando riprende l’infanzia. E in questo caso diventa anche un MacGuffin o come il filmato scolastico di First Case, Second Case, funzionale tanto a discorsi teorici, quanto a un ritratto della società iraniana dell’epoca. Spicca in questo senso anche la figura grottesca del giornalista, quella più mediocre e ipocrita del film, che sogna i grandi nomi del giornalismo mondiale nell’occuparsi di una vicenda ridicola. Vorrebbe essere come Oriana Fallaci, e cita altri nomi secondo lui fondamentali del giornalismo tra cui Peter Bogdanovich, che pure nella sua poliedricità non risulta abbia mai fatto il reporter.
Close Up è stato presentato in Italia per la prima volta al Festival di Rimini, che ora non c’è più. Lo stesso festival citato nel film, quando la notizia della presenza di Makhmalbaf nella città adriatica, per la premiazione di The Cyclist, genera i primi sospetti. Erano gli anni della scoperta del cinema iraniano e della cultura di un paese come l’antica Persia, altrimenti nota per l’integralismo religioso e lo spirito guerrafondaio. Con Close Up abbiamo scoperto un’altra faccia, diversa da quegli stereotipi. Abbiamo scoperto che esisteva il divorzio in Iran, perché Sabzian è divorziato con due figli affidati uno a ciascun ex-coniuge. Abbiamo scoperto che si poteva leggere, pur entro certi limiti, Oriana Fallaci a Teheran, considerando il famoso gesto della giornalista che si tolse il velo islamico in segno di sfida e disprezzo intervistando l’ayatollah Khomeyni.
quinlan.it









