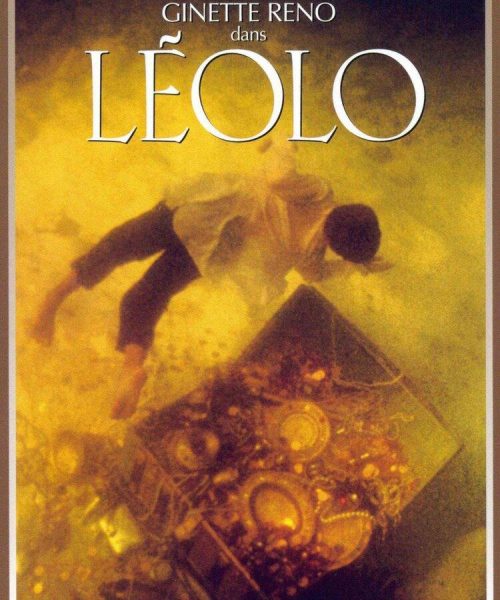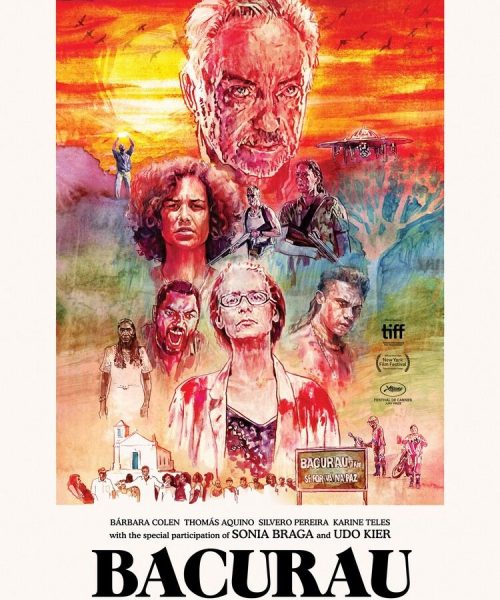Titolo originale: Lean on Pete
Nazionalità: UK
Anno: 2017
Genere: Avventura, Drammatico
Durata: 121 min.
Regia: Andrew Haigh
Charley ha sedici anni e vive insieme al solo papà, con cui da poco si è dovuto trasferire a Portland. Ama correre e un giorno, aggirandosi nei pressi di un maneggio, il ragazzo incontra Del, malandato impresario dell’ambiente ippico che lo prende con sé come tuttofare. Nella sua scuderia, Del ha un vecchio cavallo che sta per vendere, Lean on Pete, a cui Charley si affeziona nonostante gli venga ripetuto continuamente che non dovrebbe perché “un cavallo non è un animale domestico”.
Festival di Venezia 2017: Andrew Haigh si conferma regista di rara sensibilità, girando un coming of age duro e commovente, protagonista un giovane e sorprendente Charlie Plummer
Lean on Pete
Charley (Charlie Plummer) corre in continuazione, non riesce a stare fermo. A 16 anni si è curiosi ed il moto è aspetto pregnante di quel periodo della vita in cui si è attratti dalla qualsiasi; momento di dissipazione, che non è spreco ma un modo per tarare la propria capacità di saper stare appresso a tutto ciò che ci stimola. Qualcosa è come se si fosse però bloccata, quasi che il regolare funzionamento di questo meccanismo si fosse inceppato: Charley fatica a correre, non per stanchezza ma perché qualcosa glielo impedisce. Nelle prime sequenze lo vediamo per l’appunto correre, senza meta, mentre osserva, forse in cuor suo si meraviglia, ma di certo appare integrato a ciò che deve fare, qualunque cosa essa sia. È quando torna a casa che tutto finisce, non perché, banalmente, gli spazi siano ristretti: qui il giovane viene catapultato in una dimensione che non gli appartiene, la realtà, un affaraccio brutto che lo coglie prematuramente.
Il padre torna spesso a casa con una donna diversa, se la porta a letto ed il giorno dopo a Charley non resta che far conoscenza come se si fosse nella sala d’aspetto di un medico. Chiede finanche il permesso per prendersi un bicchiere d’acqua, ricevendo di tutta risposta che quella è casa sua e può fare ciò che gli pare. Allora al ragazzo non resta che uscire, correre, non per scappare da qualcosa quanto piuttosto per andare ad acciuffarla, visto che il resto delle cose gli sta impedendo di recarsi all’appuntamento. Nel corso di una delle sue scorribande, Charley incappa in un proprietario di cavalli da corsa; è qui che conosce Lean on Pete, un esemplare non di prim’ordine, perciò bistrattato dal suo proprietario, che non può fare affidamento nelle sue vittorie. Avventato, come si dovrebbe essere a quell’età, il giovane chiede e trova il modo di lavorare a stretto contatto con quel mondo lì, si trattasse anche solo di pulire la stalla. La paga è pessima, ma non importa.
Andrew Haigh ha un dono insolito, ossia quello di trovare i frammenti di vita giusti e renderli preziosi. Così come con Weekend e 45 anni, non hai dubbi di aver assistito a tutto ciò che era necessario conoscere, vedere, niente di più niente di meno. Attraverso questi stralci si stagliano dinanzi a noi, nitide, intere esistenze, senza però avere la presunzione di esaurire la loro complessità nella fattispecie presa in esame. Con Lean on Pete sembrerebbe esserci meno carne al fuoco su cui speculare, non fosse altro per l’anagrafe del protagonista: niente di più sbagliato. Per farci un’idea di ciò che sta passando Charley, ce lo dice praticamente subito Haigh, bisogna capire all’incirca che persone siano i suoi genitori, dunque in quali condizioni è maturato il segmento su cui il film si sofferma. In questo il regista inglese possiede una dote più unica che rara, in cui il tempo è componente essenziale, trattata con gli strumenti che soli possono darci contezza delle sue storie e a cui solo attraverso il dispositivo cinematografico si può attingere. Ci si pensi bene: basta spostare la lente sui titoli dei suoi due precedenti film per capire quanto tale processo stia a cuore ad Haigh, così come la sua dilatazione e restringimento (dal fine settimana dell’opera d’esordio ai quarantacinque anni condensati in ben meno tempo del secondo film).
In uno dei momenti più struggenti del film, lento, inquadratura fissa che restringe il campo (appunto) in maniera appena percettibile, c’è tutta l’apprensione per tale componente: Charley mescola presente e futuro, possibile e probabile, ottimismo e pessimismo, limitandosi a chiedere a cosa ne sarà di lui nel caso in cui accadesse qualcosa ed il suo contrario. E se vado in galera? E se invece torno a studiare? Potrei tornare a giocare a football? Quel “se” subordinato ad una cosa ed una soltanto: sarò ancora solo? Tu ci sarai? Il volto smarrito, non abbastanza però da non scorgere un seppur lieve bagliore, del giovane Plummer è sufficiente a prender parte a quell’inquietudine, quell’ansia, che è però dolce, paradossalmente gradevole. Se non altro perché ci culla, ci trasporta come trasporta romanticamente il sedicenne, il quale però vuole avere voce in capitolo su quanto gli succede anziché limitarsi a lasciarsi scolpire da loro.
Un coming of age particolare, duro, triste ma oltremodo credibile, che tramortisce come pochi lavori recenti che portano la medesima etichetta. Ci voleva un regista britannico per divincolarsi da certi stilemi, concentrandosi ancora una volta sul viaggio, così come accaduto per America Honey di Andrea Arnold. Non solo. Perché, tra le altre cose, Haigh ne indovina due in merito alle quali è difficile immaginare di meglio, ossia il titolo ed il finale, entrambi meravigliosi. L’epilogo, peraltro, speculare all’inizio, come a dire che quanto appena visto non è stata che una fase contraddistinta da svariate tappe. Ora si ricomincia, il cuore si allarga un altro po’, Charley e noi riprendiamo fiato; il tutto sulla soglia di una nuova porta. Brividi.
Recensione: cineblog.it