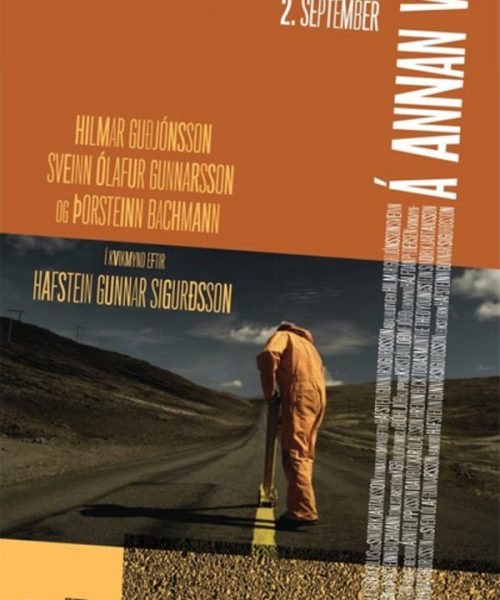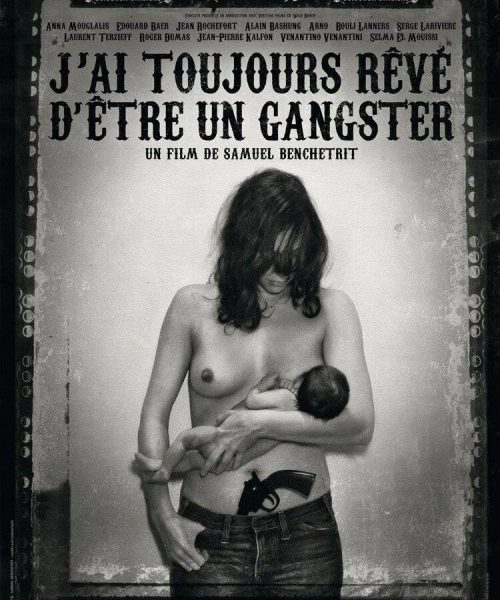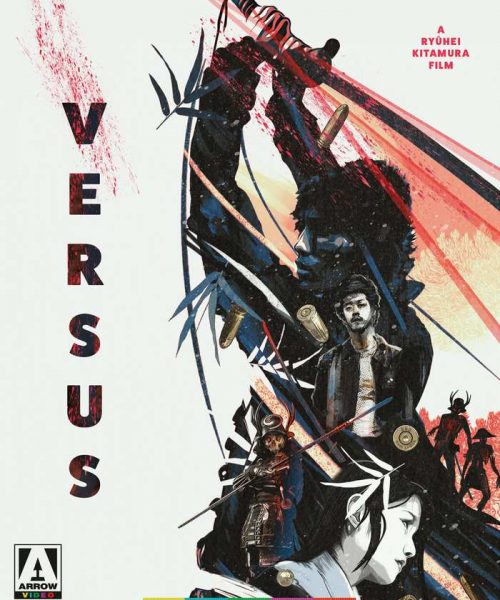Titolo originale: Sailor Suit and Machine Gun (セーラー服と機関銃)
Paese di produzione: Giappone
Anno: 1981
Durata: 130 minuti
Genere: Drammatico
Regia: Shinji Sômai
Sinossi
Izumi Hoshi, una studentessa delle superiori apparentemente innocua, diventa improvvisamente l’erede di un piccolo clan yakuza dopo la morte improvvisa di suo padre. Costretta a prendere il comando, Izumi si ritrova immersa in un mondo di omicidi, alleanze, tradimenti e strade illuminate al neon. Pur indossando ancora l’uniforme scolastica, deve maneggiare una mitragliatrice e guidare uomini adulti verso una guerra che non ha scelto, mentre scopre lati di sé che non avrebbe mai immaginato.
Recensione:
Sailor Suit and Machine Gun è una creatura strana e magnetica, sospesa tra il coming-of-age più delicato e il cinema yakuza più sporco, un incontro di opposti che solo Shinji Sômai poteva gestire con una grazia tanto feroce. L’immagine iconica di Izumi con l’uniforme da studentessa e la mitragliatrice stretta tra le braccia non è mero pittoresco: è un simbolo di un Giappone schizofrenico, dove innocenza e violenza convivono nello stesso corpo senza che nessuno trovi davvero il coraggio di guardarli per ciò che sono.
Izumi non è un’eroina badass nel senso moderno: è vulnerabile, spaesata, spesso sopraffatta, e proprio per questo irresistibile. La sua leadership non nasce da una forza innata ma dall’assurdità della situazione: gli uomini che la seguono, ben più grandi di lei, hanno la disperazione di chi ha già perso tutto, e la sua presenza diventa una sorta di miracolo imprevisto. Lei non sa nulla del mondo criminale, ma proprio questa purezza disarmata crea una forza nuova, quasi mistica. Nei suoi silenzi si sente un’eco di destino, come se fosse stata scelta da un meccanismo karmico che lei stessa non comprende.
La regia di Sômai è un flusso ipnotico: lunghi piani-sequenza che sembrano non finire mai, movimenti fluidi e avvolgenti che fanno respirare la città come un organismo vivente. Ogni angolo — vicoli, ponti, neon tremolanti — è impregnato di malinconia, come se Tokyo stessa stesse assistendo con impotenza a una tragedia annunciata. C’è quasi un tono esoterico, un senso di “predestinazione urbana” che attraversa la storia e la rende più grande di quanto sembri sulla carta.
Il film mescola generi senza vergogna: momenti di dolcezza scolastica a cui segue immediatamente la crudezza di un’esecuzione, risate leggere che vengono inghiottite da un tradimento, improvvisi slanci di tenerezza che si trasformano in visioni cupe. Questa oscillazione non è confusione, è la vita stessa di Izumi — un corpo fragile costretto a fare da ponte tra due mondi incompatibili.
L’escalation finale, con la ragazza che affronta il destino del clan stringendo la famosa mitragliatrice, è una delle scene più potenti del cinema giapponese degli anni ’80: non per la violenza in sé, ma per la trasformazione che rappresenta. Izumi rimane sempre Izumi, non diventa un mostro né un angelo vendicatore; resta una ragazza che sta cercando di non essere inghiottita dalla guerra degli adulti. E quando pronuncia il suo celebre “kyaa!”, una sorta di risata isterica e liberatoria dopo aver sparato, in quel momento sembra di vedere l’essenza stessa del film: la linea sottile dove innocenza e follia si toccano.
Sailor Suit and Machine Gun è un’opera che parla della crescita come atto di violenza simbolica, della perdita dell’infanzia come un colpo di mitragliatrice sparato troppo presto, di un mondo che pretende maturità immediata senza concedere protezione. È cinema pop, sì, ma anche una specie di rito di passaggio oscuro, orchestrato con una sensibilità che oggi manca terribilmente. È un film che non invecchia perché parla di ciò che continua a bruciarsi dentro ogni generazione: il momento in cui capire chi sei coincide con la necessità di difenderti da tutto.