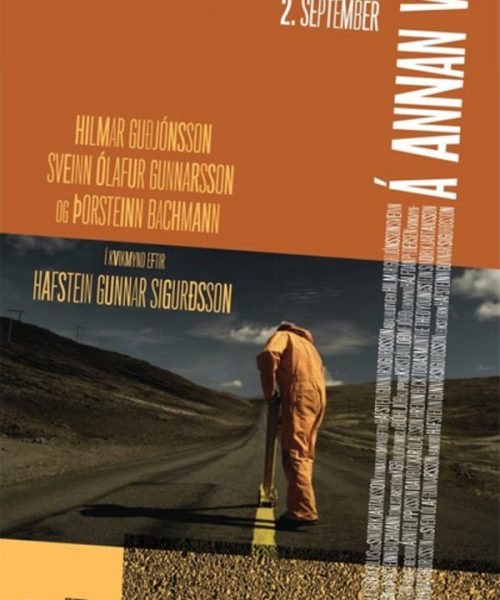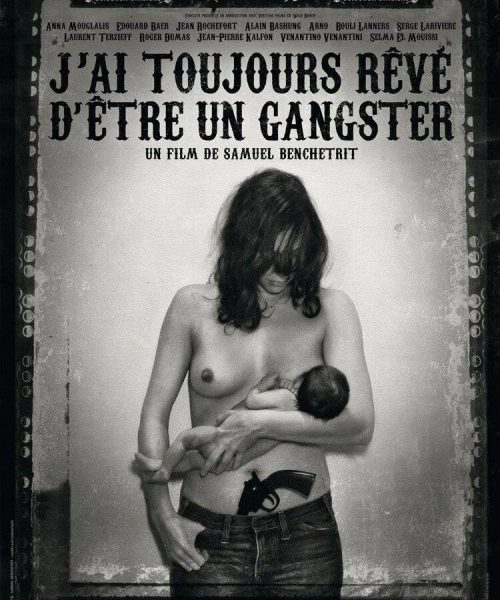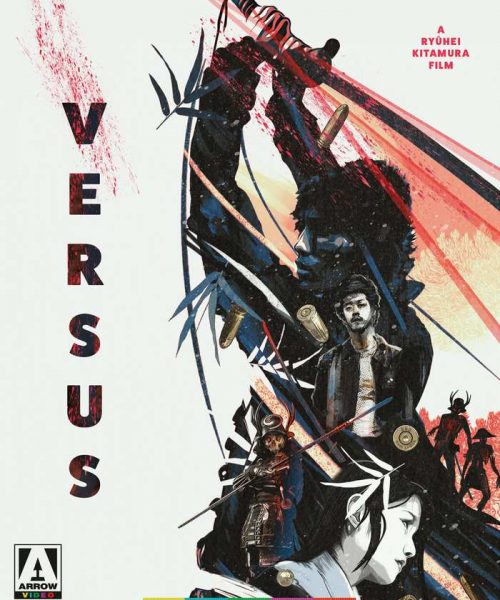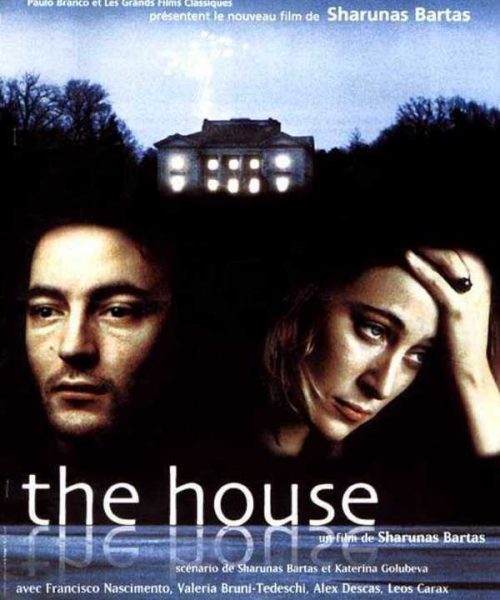Titolo originale: Pisutoru opera
Nazionalità: Giappone
Anno: 2001
Genere: Azione, Drammatico, Visionario
Durata: 112 min.
Regia: Seijun Suzuki
Conosciuta negli ambienti della malavita con il soprannome di ‘Gatta Randagia’, Miyuki Minazuki è un killer fra i più richiesti all’interno della gilda (la corporazione) dei killer professionisti. Nel corso di una missione viene però attaccata a sorpresa dal ‘Professore’, un killer costretto su una sedia a rotelle. Dopo averlo ucciso, Miyuki si accorge che una bambina, Sayoko, ha assistito a tutta la scena. Mentre Sayoko comincia a comparire ovunque, Miyuki apprende che i killer della gilda stanno combattendosi fra loro per stabilire una nuova supremazia.
Settembre 2001: quando Pistol Opera viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, la sala è piena di giovani cinefili. È probabile che molti di loro non abbiano mai visto prima un film di Seijun Suzuki, anche perché questo anarcoide signore di quasi ottant’anni (nato come Seitaro Suzuki nel 1923, ha oramai superato abbondantemente i novanta) ha da tempo smesso di girare con continuità. Tra il 1956, anno in cui esordì con tre film, Minato no kanpei: Shori o wagate ni (La vittoria a portata di mano), Hozuna wa utau: Umi no junjo (La pura emozione del mare) e Akuna no machi (La città di Satana), e il 1967 Suzuki girò la bellezza di quaranta film; nei successivi cinquant’anni o poco meno ne ha invece portati a termine nove, l’ultimo dei quali nel 2005, Operetta Tanuki Goten (Princess Raccoon), visto in Italia al Torino Film Festival nell’ultima edizione diretta dalla coppia Turigliatto/D’Agnolo Vallan. Il punto di svolta della carriera di Suzuki, destinata a passare dall’iperattività a una produzione parca, è proprio in quel 1967 nel quale il regista firma un’unica regia, La farfalla sul mirino (Koroshi no rakuin è il titolo originale). Quello che è tutt’oggi considerato il capolavoro sommo del più rilevante tra i registi dediti al noir e al gangster movie fu anche il titolo che portò la Nikkatsu a licenziare in tronco Suzuki. Un evento che ebbe dimensioni non indifferenti in patria, dove si crearono comitati in difesa della libertà autoriale, e vennero indette manifestazioni in favore di Suzuki e della sua opera.
Cosa c’entra, qualcuno potrà legittimamente chidersi, tutto questo con Pistol Opera. Tutto. Basta la prima sequenza del film, con la caduta dal tetto del primo killer, per rendersi conto di come Pistol Opera rappresenti un vero e proprio detour di Suzuki all’interno della propria filmografia, un punto di (ri)partenza che prende il via là dove tutto si era interrotto. La farfalla sul mirino era stata la pietra dello scandalo, con il presidente della Nikkatsu Kyūsaku Hori che aveva così ammonito amici e collaboratori di Suzuki: “Non abbiamo alcun bisogno di registi che girano film incomprensibili!”; ecco dunque Suzuki tornare in pista con un film che non solo riprende a grandi linee la struttura de La farfalla sul mirino, ma porta l’intera idea di cinema su cui si regge alle conseguenze più estreme. Irreparabili, verrebbe naturale definirle.
Se per Hori era incomprensibile un film come La farfalla sul mirino, chissà con quali epiteti avrebbe commentato la visione di Pistol Opera: spostando l’asse della propria estetica un passo più in là, e fondendo la dimensione da yakuza eiga che fu alla base del suo successo commerciale – l’epoca d’oro del cosiddetto muudo akushon, wesei eigo per “mood action”, deve moltissimo a Suzuki – con un avant-pop magari di maniera ma mai prono di fronte alle sfide della contemporaneità, il regista nipponico dà vita a una creatura che non ha eguali nella storia del cinema, non solo quello della terra di Yamato.
La trama è a dir poco basica, e non fa altro che contrapporre la protagonsita Miyuki, detta “Gatta Randagia”, a tutti gli altri killer che si stanno dando battaglia per primeggiare all’interno del clan. Uno schema che potrebbe irrazionalmente far pensare a una declinazione degna della reiterazione dell’era-videogame, ma che in realtà sfonda ben altre pareti. Lontano da sirene commerciali che in effetti si terranno ben alla larga da un prodotto simile, Pistol Opera è un vertiginoso calderone pop, in cui suoni, colori e scelte di inquadratura non servono solo a dare sostanza a un plot volutamente basilare, ma acquistano loro stessi il valore di “narrazione”. Il gesto estetico, che in Suzuki non è mai stato fine a se stesso, trova la sua sublimazione in un film in cui raffinatezza del movimento e istinto all’eliminazione dell’altro si muovono di pari passo. Tanto sono eleganti i gesti in scena di Miyuki e degli altri killer, quanto la barbarie prende il sopravvento, proponendo la sua incessante reiterazione di uccisioni. Un morto dopo l’altro, ecco l’elemento chiave di Pistol Opera; la morte è però raggelata, racchiusa nello sguardo geometrico, irretita dalla costruzione artificiale di uno spazio. Non c’è furia, ma crudele raziocinio nelle operazioni quotidiane di questo gruppo di assassini che si fanno fuori senza battere ciglio.
In qualche modo di lì a pochi anni un film irromperà sulla scena giapponese per controbilanciare questo sguardo: sarà il caso del sublime Izo, forse il parto più eretico della mente folgorante di Takashi Miike.
Se Izo rappresenterà il grido furibondo di un demone destinato a macellare chiunque per poter arrivare alla conclusione (anche in quel caso il quadro rilegge con occhio attento e per niente succube l’idea alla base del videogame) Pistol Opera è una polifonia mai dissonante, sempre attenta a gestire tempi e spazi, racchiudendo nella finzione pseudo-teatrale la più efferata delle azioni: l’omicidio.
Lo stile di Suzuki gioca con la memoria storica del Giappone e delle sue arti, a partire dal kabuki per arrivare a una sequenza finale incastonata nello scenario del monte Fuji (una delle tre residenze degli dei per la tradizione shintoista, insieme ai monti Tate e Haku), ma smentisce a sua volta l’epica del genere di appartenenza, svuotandolo di umanità e lasciando che i corpi siano utilizzabili proprio come le armi che impugnano. Per questo è la pistola a diventare rossa di sangue, al posto della ferita umana. “Sono pazzo!” grida l’ultimo superstite al cielo. “Sono pazzo!”. Pazzo come quel Suzuki che ha affrontato da solo le censure e le chiusure di un’industria regolamentata e strutturata in modo disumano, non poi così dissimile dal mondo di gangster e killer che ha messo in scena. Pistol Opera è una visione stordente, una rilettura di cinquant’anni di cinema che smentisce l’immagine precostituita per rifondarla di volta in volta, in una palingenesi infinita e sempre sorprendente.
Recensione: quinlan.it