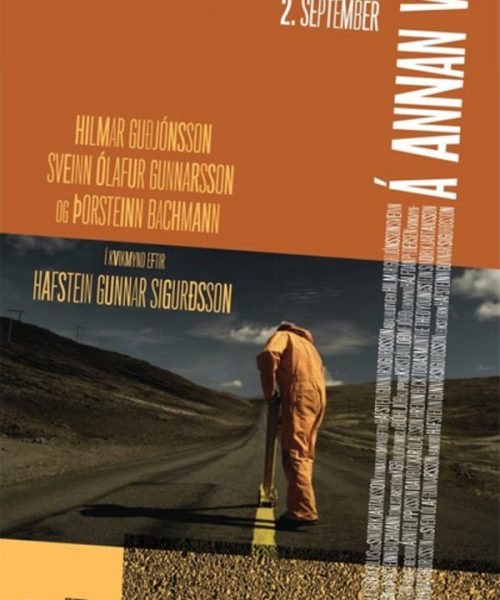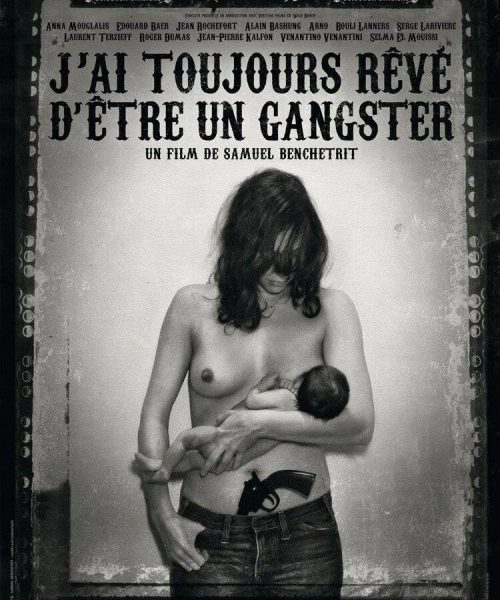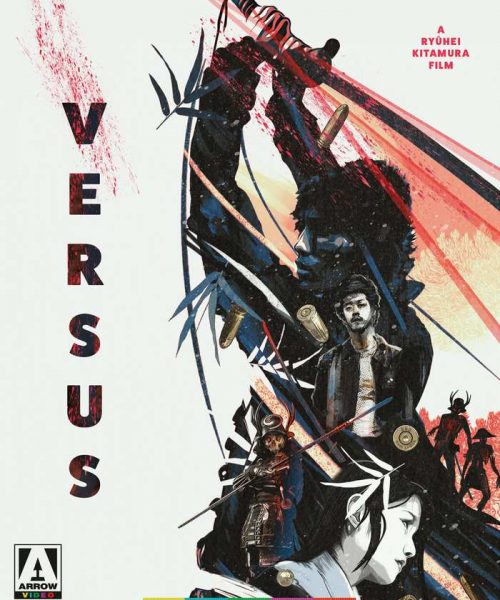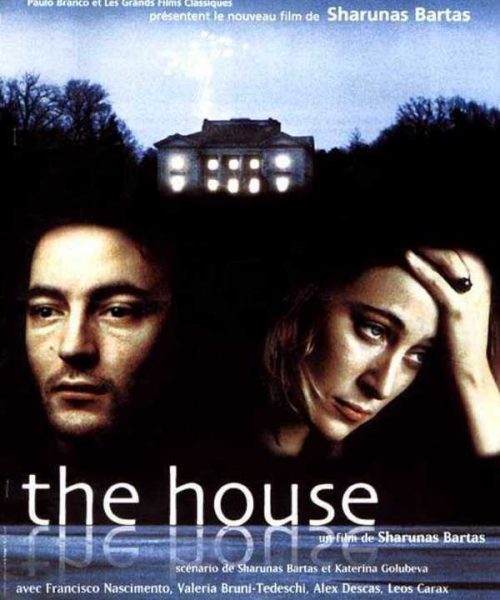Titolo originale: Melancholia
Nazionalità: Filippine
Anno: 2008
Genere: Drammatico
Durata: 450 min.
Regia : Lav Diaz
L’ultimo feedback del mondo
Due ragazze filippine, con un giovane connazionale, attraversano il Paese cambiando continuamente identità, in un estremo gioco politico, psicanalitico e rivoluzionario…
Questo mondo è un inferno, sorella.
Questo paese è un inferno.
Julian/Finto magnaccia a Rina/Finta suora
Quattro uomini in una stanza: il primo, Julian, fuma una sigaretta mentre osserva gli altri tre, due alle chitarre e uno alle tastiere, gettarsi in una jam session di totale free form rock, in cui feedback, noise e borborigmi si susseguono, finendo ben presto per accavallarsi e trascinare il tutto in un magma indistinto e assordante. Questa lunga sequenza, di fronte alla quale è realmente arduo riuscire a dimostrarsi impassibili, rappresenta forse meglio di altre il senso etico della messa in scena di Lav Diaz: una continua, nevrotica eppure apparentemente immota ricerca dell’armonia.
I personaggi dei suoi film (e in particolar modo di questo Melancholia), attraversano un mondo distorto, in evidente e tracimante saturazione, apocalittici e (mal) integrati, e vi cercano disperatamente una postura adatta; è così anche per Julian, Alberta e Rina, dispersi nella jungla dei loro sensi di colpa e delle loro frustrazioni. L’intellettuale, come già evidenziato in passato da Diaz – si veda lo splendido elogio dell’inadattabilità della poesia alle sovrastrutture del moderno presente in Death in the Land of Encantos, per esempio -, è destinato alla (auto)distruzione, perché inesorabilmente e suo malgrado scisso dalla realtà che lo circonda, vessato da un potere centrale che lo disprezza e ne intravvede in controluce la pericolosità. Non esiste scampo a questa regola, neanche quando la si cerca di infrangere contrapponendo alla sterilità del pensiero la vigoria dell’atto: anche i tre combattenti comunisti, braccati dall’esercito regolare nella jungla (questa sì, reale), che irrompono sullo schermo nell’ultimo terzo di Melancholia, in una fuga utopica a fiato rotto destinata a estinguersi sulle rive di un fiume, impalpabile e labile come le pagine fitte d’inchiostro che Renato, il rivoluzionario/poeta, lascia alla corrente, condannandole a essere slavate dall’acqua, sono l’empirica prova del crollo della ragione e dell’inarrestabile sopraggiungere dei flutti del caos.
L’accusa di Diaz cade in primo luogo proprio sullo stesso cinema filippino: la comodità alla quale si è rassegnata rappresentano meglio di qualunque altro paradigma il simbolo della sconfitta, dell’accettazione dello standard. Chinando il capo davanti alle regole dell’industria, il cinema filippino – ma, a veder bene, si potrebbe allargare il discorso all’intero percorso cinematografico mondiale – ha dato il colpo di grazia ai venti di cambiamento. È anche per far fronte a questa condizione, che Lav Diaz persiste in una messa in scena che, abbattendo paletto dopo paletto, nega completamente quello standard a cui facevamo riferimento poc’anzi: il suo non è solo un cinema extralarge, espanso a dismisura, e sarebbe completamente errato leggerlo in questa chiave. Non c’è nulla di realmente “esagerato” o trascinato all’infinito (si può trovare un’eccezione solo in alcuni campi insistiti nella jungla, ma noi vi leggiamo altresì un esempio di cinema fenomenico che non ha eguali nella contemporaneità: straordinaria, sotto questo punto di vista, la sequenza in cui Alberta cerca disperatamente la figlia adottiva durante un concerto rock, finendo per perdersi sul greto del fiume), tutto procede seguendo un ritmo ben calcolato, percepible, costante e coerente; l’opera di Lav Diaz ha un respiro che si fa al contempo epico e trattenuto, non lavora mai sul primo piano perché non gli interessa. È l’uomo nel suo contesto l’unico elemento che ha realmente valore: solo leggendo (e inquadrando) l’uomo nel panorama che lo circonda e lo sovrasta si può realmente comprendere la follia del vivere, l’aberrazione del sistema che ci schiaccia, la falsità del credo e dell’autodeterminazione (e queste due voci sono quelle letteralmente fatte a brandelli da Diaz, soprattutto nel gioco di travestimenti e illusioni di cui è cosparsa la prima metà del film), l’annichilente parvenza di felicità che inseguiamo.
Si fa sempre più disperato e lacerante, il cinema di Lav Diaz, e ogni brandello di queste sette ore e mezza ci strazia e ci confonde, trascinandoci a nostra volta nel feedback, nel caos; è così che il nostro diventa uno sguardo free form, inadeguato e necessariamente neofita – ogni volta neofita, eccola la grandezza di questo maestro del cinema mondiale. Abbiamo l’illusione di saccheggiare le inquadrature che Diaz compone con una cura abbagliante e certosina (in questo caso, rispetto al passato recente, abbiamo avuto l’impressione che Diaz abbia lavorato su inquadrature più terracee, meno liriche ed eteree), tale e tanto è il tempo che ci è concesso nell’osservarle, spiluccarle e misurarle, ma la verità è che ognuna di queste inquadrature a sua volta si insinua sottopelle e ci soggioga, mostrandoci il lato più terribile e desolato della nostra esistenza. In molti vi diranno che è impossibile descrivere la visione di un film di Lav Diaz (per lo meno, questi sono i commenti che solitamente incrociamo durante le proiezioni delle sue opere), ma voi non credetegli: la realtà è che descriverli è possibile, ma fa male. Perché è finita la lotta, e perfino la disillusione ha lasciato spazio alla tristezza: dopotutto, come scrive Renato all’adorata moglie (che mai leggerà i suoi versi), “Comprendo ora la follia lirica di questa battaglia. È tutto per la tristezza. Per la mia tristezza. Per il dolore della mia gente. Non posso rendere romantica l’inutilità di tutto questo. Anche la maestosa bellezza dell’isola non può dare una risposta a questo inferno. Non c’è rimedio a questa tristezza”.
Recensione: quinlan.it