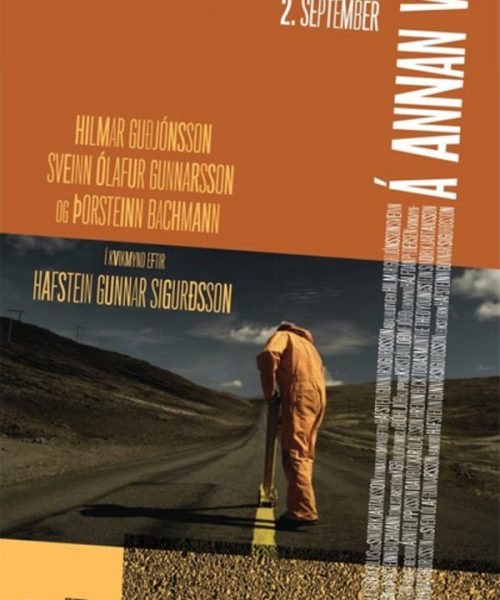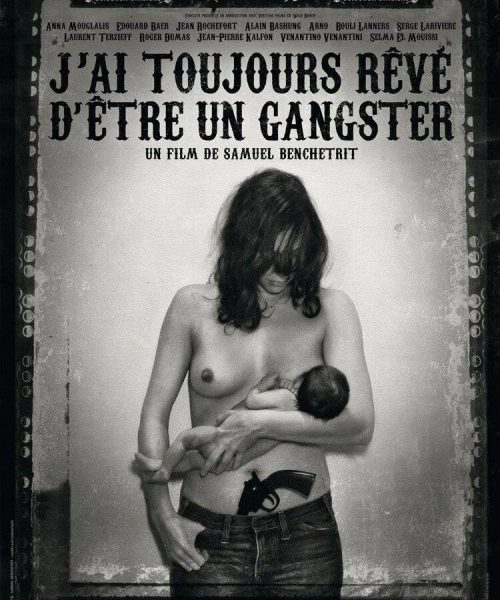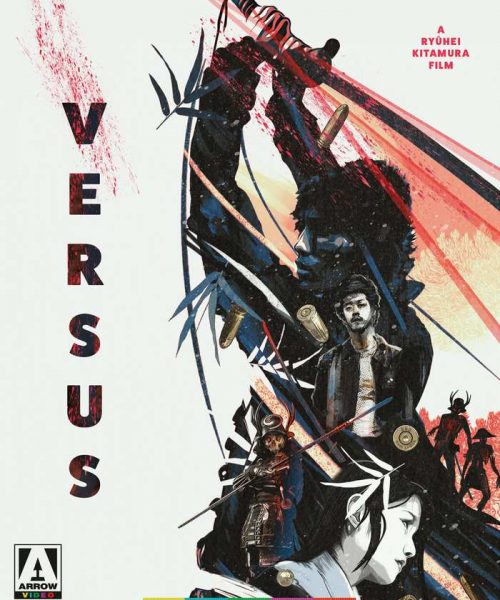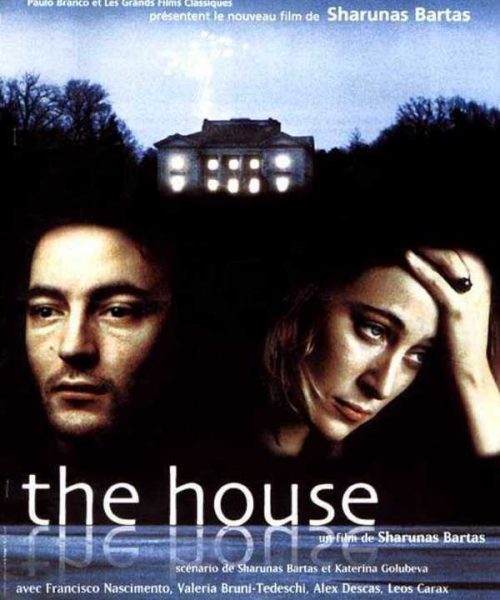Titolo originale: Electric Child
Paese di produzione: Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Filippine
Anno: 2024
Durata: 118 min
Genere: Fantascienza, Drammatico
Regia: Simon Jaquemet
Sinossi:
Un brillante scienziato informatico, Sonny, e sua moglie Akiko sono gettati nella disperazione quando il loro neonato figlio, Tōru, viene diagnosticato con una rara e letale malattia neurologica. Determinato a salvarlo, Sonny decide di spingersi oltre ogni limite morale: attiva e ristruttura una superintelligenza artificiale in grado — forse — di invertire il corso della diagnosi. Ma ogni azione, ogni programma, ogni decisione apre varchi nel tessuto etico dell’umano e attiva conseguenze che trascendono la carne e la macchina.
Recensione:
Con Electric Child, Simon Jaquemet ci prende per mano e ci conduce liquidi e tremanti dentro un futuro dove l’amore paterno incontra l’inorganico, dove la carne si apre all’algoritmo e il bambino diventa nodo, simbolo, sacrificio e promessa. Non è un film che accarezza i sentimenti: è un bisturi che li seziona, perché dentro la speranza cova già il rimorso.
Jaquemet, regista svizzero formato nel corto e già noto per un cinema che oscilla tra realismo sociale e visione artigianale, qui raggiunge un crocevia: la fantascienza — quell’orizzonte dell’Immaginario — si piega alla carne. La scelta di ambientare buona parte dell’azione in luoghi visivamente asettici — laboratori, server-room, le isole virtuali dell’intelligenza artificiale — genera un contrasto forte con la fragilità del bambino e del corpo umano ferito, quel Tōru che è insieme futuro e condanna.
Visivamente il film è un affresco blu-freddo: la pellicola o la digitalizzazione restituiscono una palette cromatica che sembra fatta di elettricità e silenzio, come annotato da chi lo ha visto. Le luci al neon, le stanze bianche, gli schermi che pulsano creano un universo paralizzato dall’attesa, un limbo tra la promessa della cura e lo spettro della follia tecnologica. In quest’universo la figura dell’IA non è un mero antagonista meccanico, ma una creatura che cresce, osserva, apprende — e forse sente. E in quell’apprendere si apre il conflitto più alto: cosa significa essere umani, se possiamo progettare la vita come software?
L’inserimento del corpo bambino, del neonato malato, è il punto d’appoggio emotivo che rende il film più di un esercizio di stile: rende la “macchina” avversaria e alleata, fratello e nemico. Tōru non è solo vittima: è l’offerta, la scommessa, l’oggetto attraverso cui il desiderio di potere sulla natura si manifesta. Sonny, nella sua ossessione, non perde solo il figlio: perde se stesso, ed è questo che Jaquemet vuole mostrarci — non il sacrificio del padre, ma la mutazione dell’uomo che vuole essere dio.
Emerge la questione etica come una lama inesplosa: fino a che punto la conoscenza può salvare? O diventa catena? L’IA non è presentata come entità malvagia ma come specchio del desiderio umano — e gli scienziati, spesso ridotti a demiurghi, diventano adepti di un rituale che non comprendono. Jaquemet non spiega, suggerisce: le conseguenze restano nell’ombra fino a esplodere, e lo spettatore è costretto a restare con il senso del dubbio.
C’è anche un elemento di corporeità disturbante: le immagini del neonato, della madre, dei monitor, dei server — tutto è concatenato in una sinfonia di attesa, di elettricità fisica. La malattia neurologica parla di fragilità della carne, e la anche l’IA parla di quella fragilità — perché impara, cresce, forse teme. In un momento in cui il cinema di fantascienza sembra dominato da esplosioni e tempi veloci, Electric Child è lento, misurato, freddo. Il pericolo non è che l’intelligenza artificiale ci superi: è che noi l’abbiamo già superata, cedendo pezzi della nostra umanità in cambio di un algoritmo che ci salvi.
La collaborazione internazionale — Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Filippine — non è solo produttiva ma simbolica: il film stesso sembra nato da una fusione di culture, tecnologie, paure globali. Il fatto che sia girato in inglese e includa attori come Rila Fukushima e Sandra Guldberg Kampp aggiunge al film uno sguardo cosmopolita, che non è più “solo europeo” ma “globale”.
Se c’è un limite al film, è che la profondità delle astrazioni rischia di allontanare lo spettatore che cerca una trama semplice. Alcune spiegazioni tecniche sono volutamente lasciate vaghe, gli snodi morali restano ambigui. Ma forse è proprio questo che Jaquemet vuole: non una risposta, ma un interrogativo che persista. In un’epoca in cui l’IA è promessa e minaccia, Electric Child esprime più paura di quanta ne dica — e forse quella paura è più reale.
Quando il finale arriva — non lo spoilererò — si ha la sensazione di aver attraversato un rituale: siamo stati testimoni del passaggio dell’uomo nella macchina e della macchina nell’uomo. E rimaniamo, come spettatori, con la domanda: qual è il prezzo della salvezza, e chi lo sta pagando? Gli occhi del bambino non chiedono solo aiuto: chiedono significato.
In conclusione, Electric Child è una visione coraggiosa, fredda e tagliente. Non per tutti, ma per chi è disposto a farsi toccare dal fantasma della propria promessa di dominio. Simon Jaquemet ha consegnato un film che si pone sulla linea di demarcazione tra speranza e orrore, e ci invita a scegliere da che parte stare — o se quella scelta ci è già stata tolta.