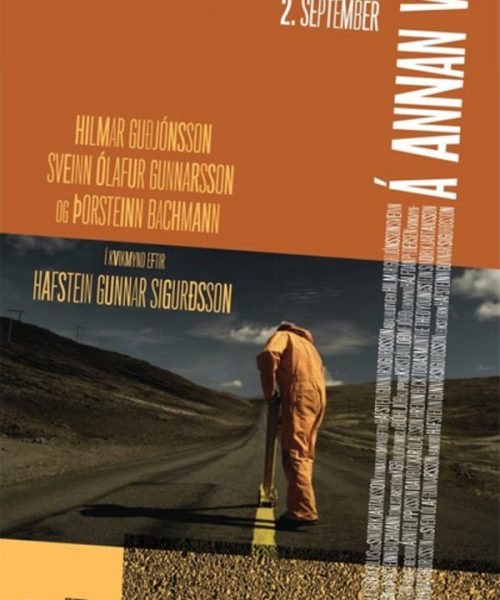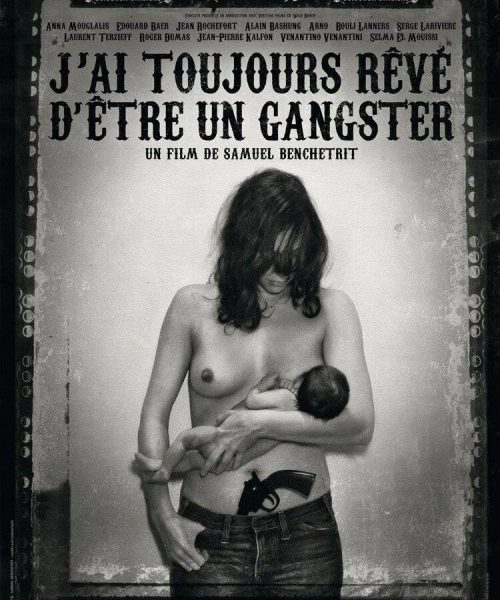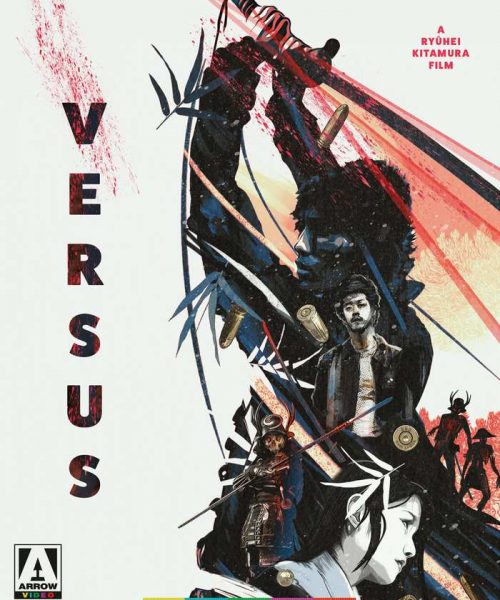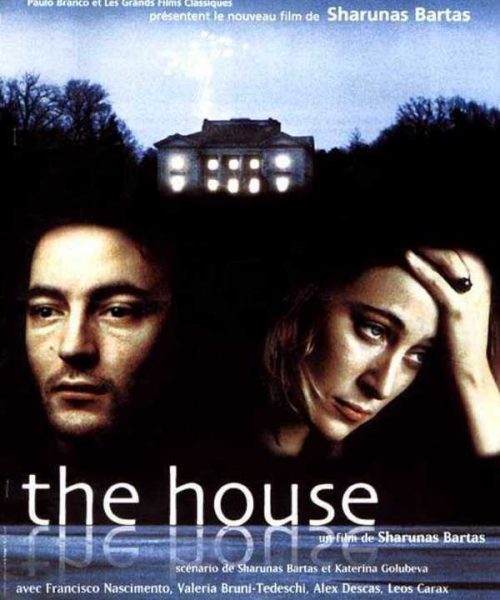Titolo originale: Now Showing
Paese di produzione: Filippine, USA
Anno: 1998
Durata: 4h 40min
Genere: Drammatico
Regia: Raya Martin
Rita è un’adolescente che deve il suo nome a una star del cinema che sua nonna, un’ex attrice ora deceduta, adorava. Vive in un vecchio quartiere di Manila insieme con la madre, una signora sempre indaffarata che ama guardare film alla televisione, e la zia imprenditrice. La sua vita da ragazzina viene raccontata giorno dopo giorno attraverso scene di routine quotidiana, ma anche ricorrendo a spezzoni di vecchi film degli anni ’30. Tempo dopo, cresciuta e diventata indipendente, Rita lavora come commessa nel negozio di dvd della zia: nel vuoto di un’esistenza sempre uguale a se stessa, riesce però a trovare la voglia di cambiare e a lasciare Manila.
Sussistono dei presupposti ontologici necessari per poter apprezzare Now showing di Raya Martin, perché quello filippino non è solamente un cinema che si fa cinema, che lavora sul cinema, ma è anche, e forse soprattutto visto che non scade in un’asettica operazione d’analisi o di metacinematografia, un congedo rispetto a un’epoca, a una cultura, il che nel film viene progressivamente letto e poi tradotto come un congedo al cinema, quindi il primo presupposto: il cinema è cultura, ma bisogna fare attenzione a quale specie di culturalità viene affidata al cinema, anzi è proprio quest’affidamento al mezzo cinema come apparato o sistema di registrazione che fa successivamente emergere la cultura dal cinema, la memoria dal film. Il processo che porta dalla qualità del VHS a quella dell’HD è non solo il movimento formale del film, strutturato attraverso differenti stratificazioni qualitative (il film inizia appunto da – attenzione, non «con» – una certa qualità dell’immagine e si consuma nel solluchero dell’alta definizione), ma è anche il vortice attraverso il quale l’individuo, registrando se stesso, il suo passato, si spersonalizza, affida cioè la propria individualità alla generalità dell’immagine digitale, e basterebbe comparare, semplicemente, questo profondersi della memoria nell’oralità dell’inizio (l’oralità della storia, del racconto da persona a persona) e nella catalogazione silenziosa della fine (il negozio di film) per avere sensibilità e percezione di questa smagnetizzazione della persona dal proprio polo attrattivo, ovvero se stessa, com’era stata in passato, in un’altra vita, sotto le sembianze dei propri avi eccetera; il racconto che viene fatto a Rita, infatti, è mitico: racconta della madre di lei in maniera circolare e fondativa, identitariamente fondativa, ed è qualcosa di segreto nella sua platealità, qualcosa da ricordare perché soltanto un tempo plateale, e il ricordo, in questo caso, è identificante, perché si fa di un passato omogeneo qualcosa di eteroclito attraverso la singolarizzazione di questo per mezzo del ricordo, il quale, essendo nella persona, si commistiona con la persona, è proprio della persona. E questo solo può accadere, poiché la rappresentazione di ciò che non c’è più può avvenire solo internamente e intimamente, visto che gli apparati di registrazione, allora, erano quel che erano (fondamentale il fatto, a questo proposito, che l’audio venga a mancare proprio nei momenti della rappresentazione, quali il canto di Rita e la recita dei bambini). Il livello culturale-individuale è così indifferente nella sua bipolarizzazione, quasi un termine non potesse sussistere senza l’altro, ma l’affinamento delle tecnologie e l’affidamento di questa o quella mansione (la preservazione della memoria, della culturalità e dell’individualità, in questo caso) a suddette tecnologie porta alla scissione del nucleo originario in cui, appunto, culturale e individuale erano strettamente collegati, facendo in modo che l’individuo, registrando, ponendo il ricordo fuori di sé, incaricando qualcosa di esterno alla preservazione del ricordo, delocalizzi nient’altro che se stesso, quell’individualità che lo individualizza e che, ora assente, rende la persona una specie di schizofrenico inidentitario perché pluridentitario, e di questo prova è il silenzio finale, nonché la solitudine derivante dall’estraneazione di Rita dalla società in cui un tempo era particella. Una morte della cultura per mezzo del cinema? No, piuttosto una sconfitta del cinema, e vuoi anche dell’individuo, perché Raya Martin è politica, sì, ma cinematograficamente, e in tutto questo, ciò che emerge, non è altro che l’impotenza del cinema, che registra e non crea, impotenza derivata dal fatto, appunto, che si è abbandonato il cinema, non lo si è affiancato all’individuo, a una certa forma di cultura, ma, alla deriva, ne si è fatto mezzo cui far emergere la cultura, una cultura d’altri tempi però, il cui oblio è correlato, come si è detto, alla spersonalizzazione dell’individuo, che ora manca di cultura, non fa cultura ma l’affida, e questo, prima ancora che decretare la morte della persona (Raya Martin ha questo di buono: non è esistenzialista), sembra portare, ineluttabilmente, alla monotonia del cinema, alla sua superficialità e inutilità.
emergeredelpossibile.blogspot.com