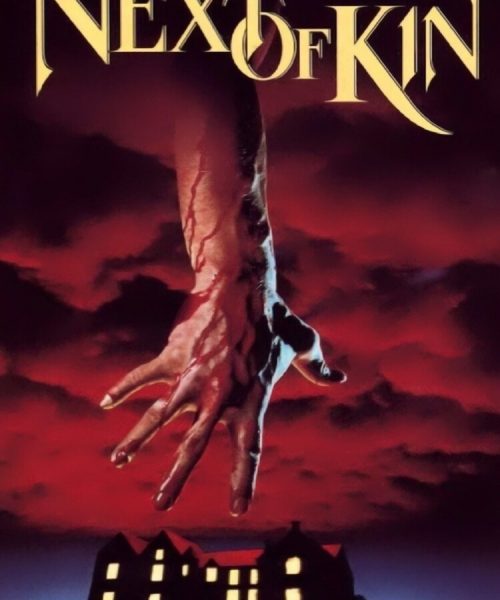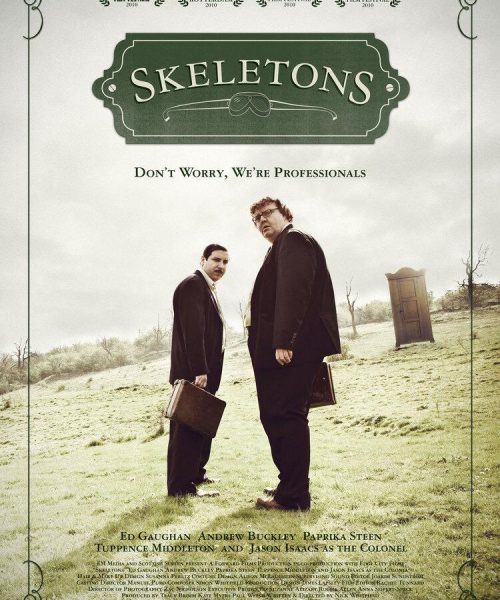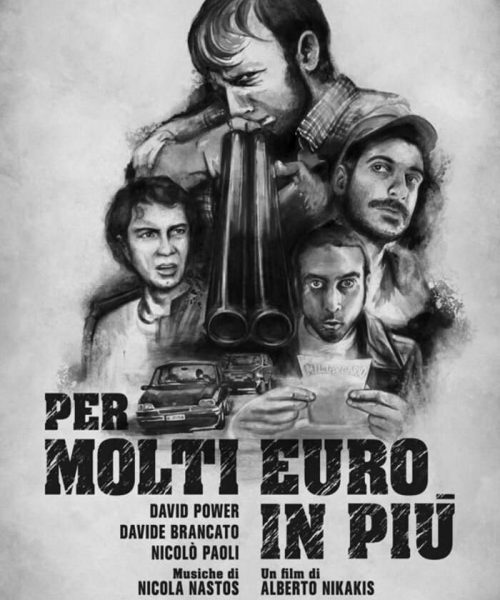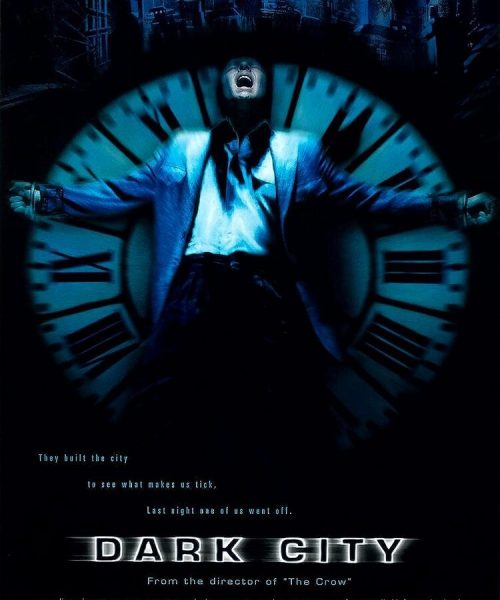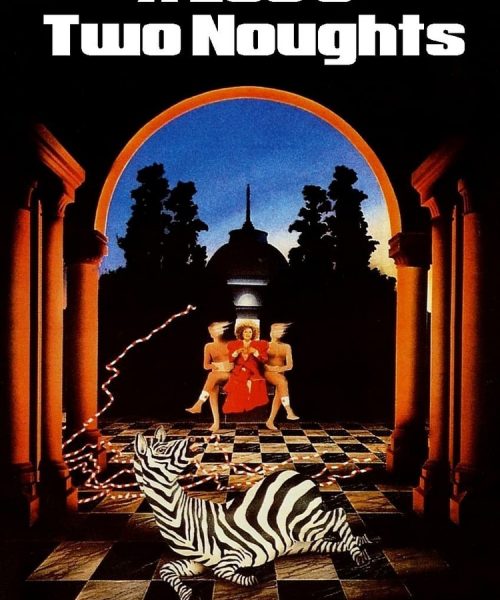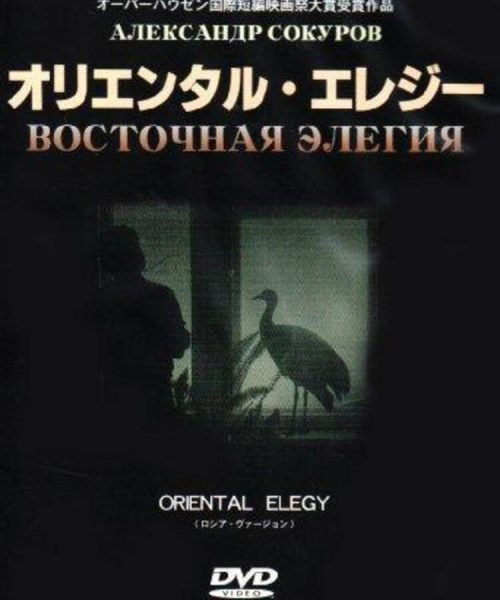Titolo originale: Shokuzai
Titolo internazionale: Penance
Nazionalità: Giappone
Anno: 2012
Genere: Drammatico, Serie TV
Episodi: 5
Durata: 270 min. [stagione unica]
Regia: Kiyoshi Kurosawa
Senso di colpa
Una giovane studentessa di nome Emili si trasferisce da Tokyo nella scuola elementare della piccola città di Ueda e diventa amica di Sae, Maki, Akiko e Yuka. Un giorno Sae scopre di essere stata vittima di un furto. Tornate a scuola, mentre giocano a pallavolo, un uomo chiede a Emiri di seguirlo per dargli una mano in palestra. Quando le altre non la vedono tornare, iniziano a cercarla finché non la trovano morta. Ma le ragazze non ricordano il viso dell’uomo e l’impossibilità di ritrovarlo segnerà per sempre le loro vite.
La sessantanovesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, com’è oramai universalmente noto, ha visto selezionate solo opere in anteprima mondiale: un dato sempre più ricorrente all’interno dei circuiti dei grandi festival (oltre a Venezia, Cannes e Berlino, oltre al festival di Roma sotto l’egida di Marco Müller), con i direttori artistici tesi alla continua ricerca del “mai visto”. Anche la Mostra del Barbera-bis, dunque, si piega a questa consuetudine, o almeno così pare… Esiste infatti, nel bailamme di titoli che compongono il programma della kermesse lidense, un film che è in anteprima mondiale pur essendo stato visto in Giappone da un numero considerevole di persone. Il perché di questa strana anomalia è presto detto: prima di diventare una monumentale opera cinematografica in grado di attestarsi sulle quattro ore e mezza di durata, Penance (il titolo internazionale è la traduzione letterale dell’originale giapponese Shokuzai) è stata una mini-serie televisiva. La messa in onda, nel gennaio del 2012, è stata attesa da un gran numero di spettatori in patria, un dato che non deve assolutamente stupire visto che il film è tratto dalla terza fatica letteraria di Kanae Minato, romanziera molto attenta alla psicologia femminile e al tema della vendetta, e autrice in passato anche di Confessione, da cui Tetsuya Nakashima ha tratto l’ottimo Confessions, visto in Italia al Far East di Udine e acquistato per la distribuzione nazionale dalla sempre benemerita Tucker Film. Se Nakashima aveva tradotto in immagini le parole scritte dalla Minato facendo ricorso a un’impostazione avant-pop deflagrante e a tratti stordente – riuscendo in pieno a cogliere la confusione ipercinetica ed emotivamente instabile dei protagonisti –, Kiyoshi Kurosawa, tra i più grandi metteur en scène del cinema nipponico dell’ultimo ventennio (alla pari forse solamente di Takashi Miike, Takeshi Kitano, Sion Sono e Satoshi Kon), attinge alla propria esperienza autoriale, trasformando Penance da prodotto popolare a pianeta a parte, universo a se stante dotato di una propria unicità espressiva. Nelle pieghe di Penance sembra di poter riconoscere gli universi malati e sofferti di Doppelganger, Loft, Retribution e via discorrendo: anche la fascinazione per la morte, la continua irrequieta tensione alla solitudine e allo sconforto che si respirava a pieni polmoni in Pulse – probabilmente a tutt’oggi la sua opera più illuminante, insieme al solitamente sottostimato Bright Future – trova punti di contatto con la tragica vicenda da cui si protendono i fili invisibili che avvincono tra loro le cinque protagoniste di Penance. Tutto ruota attorno a un fatto avvenuto quindici anni prima della narrazione: un pomeriggio, nella palestra di una scuola elementare, una bambina fu seviziata e uccisa da uno squilibrato. La madre della piccola vittima strinse un patto con le quattro amichette del cuore della figlia, da lei considerate colpevoli di essersi disinteressate del destino della bambina e di non riuscire a ricordare nessun dettaglio rilevante riguardo l’assassino, visto da tutte in volto. Quindici anni dopo, per motivi del tutto estranei tra loro, i nodi iniziano a venire al pettine…
Il film, riproducendo in tutto e per tutto la struttura narrativa pensata per la televisione, si suddivide in cinque capitoli, anticipati da un prologo grazie al quale il pubblico viene messo al corrente di quanto accaduto quindici anni prima: i capitoli focalizzano l’attenzione di volta in volta su una delle cinque donne, lasciando che spetti alla madre chiudere la lunga maratona cinematografica. Dalla storia di Sae, che a ventiquattro anni non ha ancora mai avuto le mestruazioni e ha al contrario sviluppato un terrore incontrollabile nei confronti degli uomini si passa a Maki, seria e fin troppo rigorosa maestra elementare che si impegna negli allenamenti di kendo; è poi la volta di Akiko, che si ritiene poco più che un’orsa e ora vive rinchiusa in un ospedale psichiatrico, e infine di Yuka, da sempre innamorata dei poliziotti e invidiosa delle attenzioni ricevute dalla sorellina Mayu. Quattro ritratti di donne che vivono sul crinale della crisi, schiacciate dal senso di colpa per qualcosa su cui non hanno davvero responsabilità: su tutte loro aleggia l’ombra opprimente di Asako, la madre della morta, che racchiude all’interno della sua personalità le ossessioni, le paure e le idiosincrasie di un mondo in dissoluzione, aggrappato a certezze che oramai non esistono più (o forse non sono mai esistite). L’umanità di Penance non viene sconfitta dal fato o dalla concatenazione degli eventi, ma nasce già sconfitta, distrutta, sospinta a vele spiegate verso il fallimento: in un contesto del genere, la speranza non può che essere soffocata e derisa, e anche il compimento della vendetta – o della “giustizia”, se questo termine può avere ancora senso nel cinema di Kurosawa – rimane confinato nella sterilità. Interpretato da un cast di assoluto livello, che unisce la sempre splendida Kyoko Koizumi a un quartetto di promesse attoriali (Yu Aoi, Eiko Koike, Sakura Ando e Chizuru Ikewaki), Penance è un Kurosawa classico e innovativo allo stesso tempo, visto che se le timbriche umbratili rispettano in pieno l’indole kurosawiana il ritmo della messa in scena è decisamente meno riflessivo e compassato. Il tempo in cui si svolge l’azione, pur all’apparenza dilatato – ma le quattro ore non risultano mai ostiche per la visione – è in realtà iper-compresso, le inquadrature si susseguono a un ritmo vertiginoso per gli standard del cineasta nipponico e anche l’utilizzo della macchina da presa devia in maniera sensibile dal percorso intrapreso finora. Una scelta a suo modo spiazzante, ma che serve a rinverdire ulteriormente l’universo poetico di Kurosawa, confermandone il ruolo di primaria importanza all’interno delle dinamiche cinematografiche contemporanee.
Recensione: quinlan.it