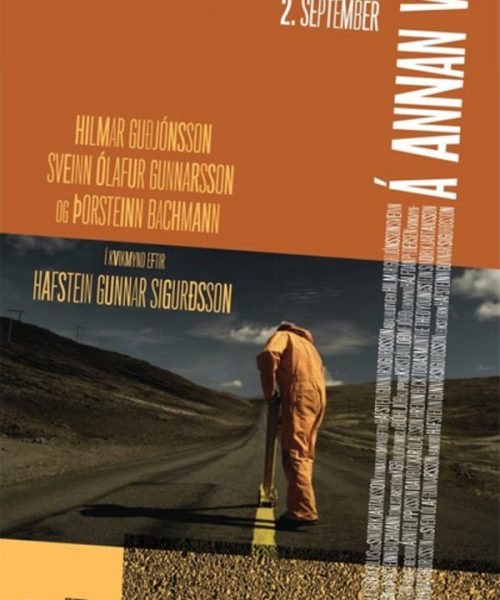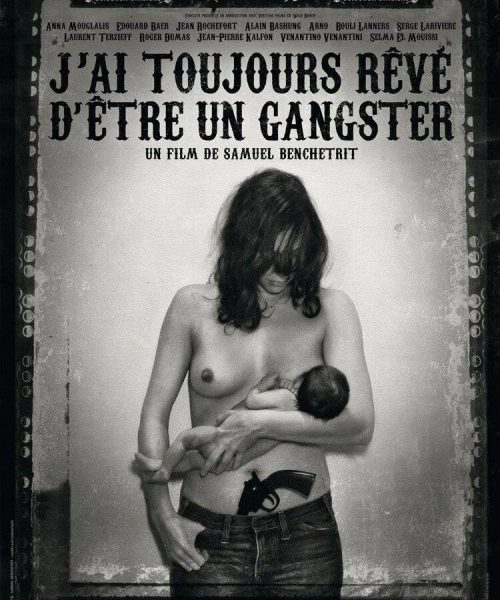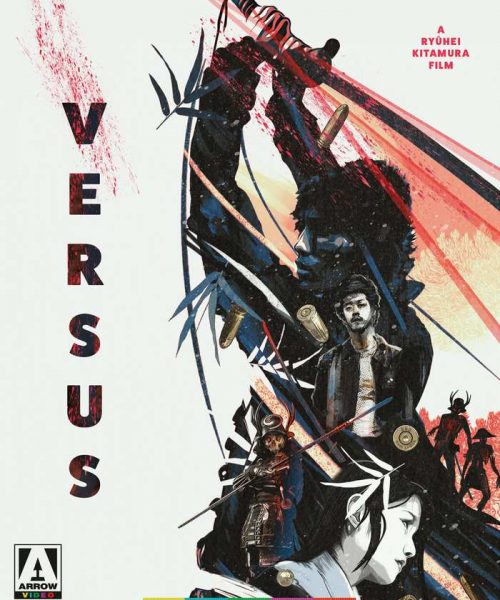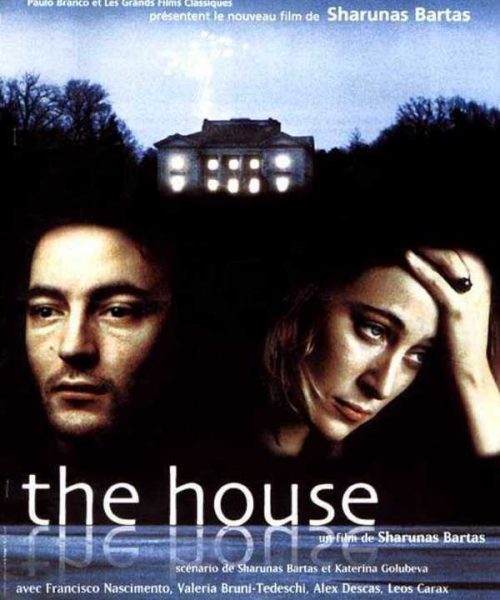Titolo originale: Szürkület
Paese di produzione: Ungheria
Anno: 1990
Durata: 105 minuti
Genere: Noir, Drammatico, Thriller
Regia: György Fehér
Sinossi:
In un villaggio remoto sconvolto dall’omicidio di una bambina, un investigatore solitario arriva per ricostruire i fatti. La comunità è chiusa, ostile, impenetrabile; il sospettato principale è un uomo fragile e disadattato che sembra confessare e ritrattare in un ciclo senza fine. Mentre il caso avanza, l’indagine si trasforma in un lento naufragio morale: più l’ispettore cerca la verità, più il mondo attorno a lui sembra inghiottirlo in una nebbia di colpa, fatalismo e silenzi indecifrabili.
Recensione:
“Szürkület” è uno di quei film che arrivano come un temporale senza tuono: non fanno rumore, non cercano di impressionare, ma una volta entrati ti ritrovi inzuppato nell’oscurità fino alle ossa. Fehér costruisce un noir che non ha nulla a che vedere con le regole canoniche del genere: niente ritmo serrato, niente colpi di scena, niente soluzioni. Qui il noir è una forma di meditazione, un sacrario di ombre dove la tensione non esplode mai, ma pesa, grava, schiaccia.
La prima cosa che colpisce è la fotografia. Bianco e nero abissale, granitico, tagliato come un altare funebre. Le immagini sembrano sospese tra il sogno e la decomposizione, con quella nebbia persistente che non è un effetto visivo: è la condizione esistenziale dei personaggi. Le luci basse, i volti che emergono appena, le silhouette immobili: tutto parla di un mondo dove la morale è evaporata e ciò che resta sono forme, residui, accenni di umanità che forse non ricordano più cosa significhi essere vivi.
L’indagine poliziesca è un pretesto. La ricerca dell’assassino serve solo a mostrare un’altra ricerca, quella vera: capire se la verità esiste ancora in un mondo così eroso. L’ispettore, con la sua calma affaticata, sembra più un pellegrino che un investigatore. Ogni dialogo è un enigma, ogni testimonianza un detrito emotivo. Non c’è fiducia, non c’è comunità: solo individui isolati che si muovono come se portassero sulle spalle un destino già scritto.
E poi c’è l’uomo sospettato. Una figura dolente, ambiguamente colpevole, ambiguamente innocente. Fehér lo riprende come se fosse intrappolato in una dimensione parallela: un uomo che non capisce il linguaggio del mondo, un capro espiatorio vivente, un bersaglio per una società che ha fame di punire qualcuno per qualcosa — qualsiasi cosa — pur di non guardare dentro se stessa. La sua presenza destabilizza perché non permette allo spettatore di scegliere da che parte stare. La sua colpa resta sospesa, come tutto il resto.
Il film è ossessionato dal concetto di limbo. Le foreste nude, le strade fangose, le case che sembrano abitate da fantasmi vivi: tutto induce la sensazione che il villaggio sia un punto di passaggio tra due mondi. È un luogo dove il male non è un atto, ma un clima. Non è un colpevole da catturare, ma una malattia che si respira. E l’ispettore, intrappolato nella ricerca, diventa parte di questo clima: il suo volto si spegne, i suoi occhi si opacizzano, la sua volontà vacilla.
“Szürkület” ha una lentezza ipnotica, ma mai gratuita. Ogni passo è calibrato per aumentare il disagio. È un film che vive di omissioni, di tempi morti, di silenzi: come se Fehér volesse affermare che l’orrore non sta negli eventi, ma nell’attesa. E a mano a mano che l’indagine procede, lo spettatore capisce che non arriverà nessuna rivelazione salvifica. La verità non è un punto di arrivo, ma un’assenza che continua a svuotare tutto.
Il finale è uno dei più crudeli e poetici del cinema dell’Est europeo: non chiude, non libera, non risolve. Semplicemente lascia andare, come se i personaggi fossero destinati a perdersi per sempre in un crepuscolo eterno, in una stasi che non concede redenzione. È un’opera sul fallimento: della giustizia, della comunicazione, della memoria, dell’umano. Eppure, nella sua oscurità totale, resta una luce minima — la luce della consapevolezza, della percezione che questo buio dice qualcosa di profondamente vero sulla nostra condizione.
“Szürkület” non intrattiene: ti affonda. E lo fa con una grazia funebre, con una precisione lirica che vibra come una preghiera pronunciata troppo tardi.